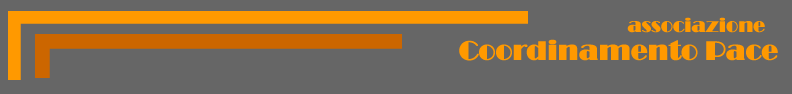|
| |
| |
|
 |
| |
COORDINAMENTO PACE
aderisce a:
|
 |
CINISELLO CITTA' APERTA
Per una pratica dell'antirazzismo
nel Nord Milano |
| |
Nel nostro paese nessuno E' straniero nostra patria
e' il mondo intero |
| |
 |
| |
 |
|
|
|
Archivio>> Irak >>Documenti |
| |
|
|
| |
| Articoli |
 |
A Nassiria per difendere il "nostro" petrolio
Presentato “Truffa
a mano armata”, rapporto che racconta il sacco del greggio iracheno
Sabina Moranti, Liberazione,
14 febbraio 2006 |
 |
Mano italiana
nelle torture Abu Ghraib
23 febbraio, 2006 - tratto da Unimondo |
 |
Babilonia militare
Fabio Mini,
generale dell'esercito, già capo di Stato maggiore del comando Nato
delle forze alleate Sud Europa, ed ex comandante della missione Kfor in Kossovo. |
 |
Iraq: e ora?
Nino Sergi,
Segretario generale di Intersos, pubblicato su www.vita.it, il 12/06/2006
(titolo originale «Il Governo ora metta a punto il programma di cooperazione») |
 |
Grandi manovre petrolifere per il bottino di guerra in Iraq
Fabio Alberti,
presidente ONG Un ponte per... 18 giugno 2006 |
 |
Nassiria, pozzo senza fondo
Gianluca Di Feo, L’espresso, 11 maggio 2006 |
 |
Un'ipotesi per il ritiro dall'Iraq
Gianni Rufini,Gianni
Rufini, Università di York - Post-war Reconstruction and Development
Unit lunedì 29 maggio 2006. Scritto per Lettera 22 su www.socialpress.it |
 |
In
Iraq la guerriglia spara con pistole italiane
La Stampa, 24 Febbraio 2006 |
 |
Football e pizza - Così gli USA si preparano a restare in Iraq |
 |
Il destino dell'Iraq
Tarik Ali trad.it. di Alessandro Siclari per NuoviMondiMedia, Tariq
Ali The Guardian, 16 gennaio 2006 |
 |
Missione italiana sotto inchiesta
Un ponte per... - Osservatorio Iraq 18 gennaio 2006 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
A Nassiria per difendere il "nostro" petrolio
Presentato “Truffa
a mano armata”, rapporto che racconta il sacco del greggio iracheno
Sabina Moranti, Liberazione,
14 febbraio 2006
Per quelli che non avevano creduto alla favoletta dell’esportazione
della democrazia il dossier “Truffa a mano armata - I numeri degli interessi
petroliferi occidentali e italiani dietro la guerra all’Iraq”
non è una sorpresa ma, avere le cifre della razzia aiuta a fare piazza
pulita della retorica. Frutto del lavoro della britannica Platform - ong che
si occupa di monitorare il comportamento delle multinazionali del petrolio
nel mondo - il rapporto è stato tradotto in italiano grazie al lavoro
congiunto di Un Ponte per…, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale,
Lunaria ed Arci ed è stato presentato ieri a Roma alla presenza di
alcuni rappresentati della General Union of Oil Employees di Bassora, il sindacato
dei lavoratori del petrolio del sud dell’Iraq, venuti a raccontare cosa
significa lavorare nell’Iraq occupato dalle truppe e dalle multinazionali
d’Occidente, e a illustrare modalità diverse per sfruttare la
risorsa petrolio a beneficio dell’intera popolazione.
“Truffa a mano armata” denuncia il percorso di appropriazione
del petrolio iracheno da parte delle multinazionali, una spartizione che non
passa attraverso l’esplicita privatizzazione - tentata nei primi giorni
dell’occupazione ma subito abortita - ma che viene imposta attraverso
l’adozione di contratti che, pur lasciando all’Iraq la proprietà
nominale dei giacimenti di fatto mettono in mano alle multinazionali la maggior
parte delle rendite future. Grazie a questi accordi infatti, ben 63 degli
84 giacimenti iracheni vengono riservati alle multinazionali del petrolio.
Tra queste non poteva mancare l’italiana Eni che, come dimostra un documento
allegato al dossier, insieme alla britannica Bp, alla statunitense Chevron
e alla francese Total, sta lavorando direttamente con il ministero del Petrolio
di Baghdad per definire il piano di sviluppo dei giacimenti petroliferi presenti
nel sud dell’Iraq, dove si trova appunto Nassiriya e dove i nostri soldati
sono stati spediti - e sono morti - proprio per questo motivo.
Non stiamo parlando di vaghi principi relativi alla sovranità nazionale:
le proiezioni dei dati economici fornite da Platform mostrano che il modello
di sviluppo petrolifero ideato dal Dipartimento di Stato Americano costerà
all’Iraq centinaia di miliardi di dollari in mancante entrate.
Nell’introduzione del rapporto si legge «Nel caso dello sfruttamento
del giacimento di Nassiriya da parte dell’Eni, per deduzione dalle proiezioni
aggregate di Platform, le mancate entrate per lo Stato iracheno oscillerebbero
tra i 2,3 ai circa 6 miliardi di dollari, pari rispettivamente all’8
ed al 20 per cento del bilancio annuo attuale dell’Iraq». E stiamo
parlando di un unico giacimento, e nemmeno dei più importanti. Niente
male per un paese che dovrebbe avere accesso a ogni possibile risorsa per
ricostruire delle infrastrutture rese fatiscenti dalle sanzioni e poi distrutte
dai bombardieri.
Scarica
il rapporto (pdf)
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Iraq: mano italiana
nelle torture Abu Ghraib
23 febbraio, 2006 - tratto da Unimondo
I mezzi di informazione tornano a parlare delle torture avvenute nel carcere
di Abu Ghraib grazie all’intervista esclusiva realizzata da Sigfrido
Ranucci e Maurizio Torrealta di Rainews24 ad Ali Shalal al Kaisi, l'uomo incappucciato,
la cui foto ha fatto il giro del mondo.
Al Kaisi è stato raggiunto ad Amman, in Giordania, mentre seguiva un
corso per "Non violent action for Iraqi", tenuto da alcune Ong europee,
in qualità di fondatore dell´Associazione delle vittime delle
prigioni americane. Per la prima volta Ali Shalal al Kaisi racconta le terribili
torture a cui e´ stato sottoposto nel carcere iracheno.
"Ogni volta che usavano gli elettrodi - è l'agghiacciante racconto
- sentivo gli occhi che fuoriuscivano dalle orbite. Una scossa e´ stata
talmente forte che mi sono morso la lingua e ho cominciato a sanguinare. Sono
quasi svenuto. Hanno chiamato un dottore, che ha aperto la mia bocca con gli
stivali, ha visto che il sangue non veniva dallo stomaco ma dalla lingua e
ha detto: continuate pure", ricorda Ali, che, mostrando la sua mano deturpata,
aggiunge: "Con gli stivali calpestavano continuamente la mia mano ferita".
Tra le testimonianze da lui raccolte anche quella di un ex diplomatico iracheno,
Haitham Abu Ghaith, secondo il quale, come racconta Al Kaisi nell´intervista
a Rai News 24, a condurre i tremendi interrogatori dei prigionieri c´erano
anche contractors italiani ingaggiati da ditte americane.
Ma Ali Shalal el Kaissi non perdona ai nostri connazionali di aver trafugato
soldi e reperti archeologici. "Noi amiamo il popolo italiano, conosciamo
la differenza tra la popolazione civile e chi compie questi gesti, ma questo
non ci impedisce di denunciare cosa facevano gli italiani.
Il messaggio che voglio dare al popolo italiano e’ che in Irak la situazione
non e’assolutamente migliorata, nulla e’ stato ricostruito".
Il governo, secondo il premier Berlusconi, non era al corrente di nulla, se
poi c'era qualche mercenario il problema non riguarderebbe a suo dire il nostro
governo.
Sulle dichiarazioni interviene il senatore Francesco Martone, segretario della
commissione diritti umani, che ricorda a Berlusconi la “Convenzione
internazionale contro il reclutamento di mercenari”, attualmente ratificata
da 25 stati, tra cui l’Italia, che ha posto la sua firma nel 1995 durante
il suo primo governo.
Secondo il parlamentare di Rifondazione la vicenda dovrebbe interessare molto
sia il suo governo che la magistratura. “Berlusconi, con la sua dichiarazione
fa finalmente luce, forse inconsapevolmente, sul vero mestiere del contractor,
che è quello del mercenario né più e né meno.
Il governo avrebbe dovuto da tempo prevedere delle normative che regolassero
le attività delle compagnie di sicurezza private italiane ed evitare
che alcune di esse potessero diventare centri di reclutamento per persone
che in realtà sono mercenari a tutti gli effetti.”
Secondo un rapporto dell'organizzazione umanitaria Human rights first - reso
pubblico il 22 febbario a New York - sono 98 i prigionieri morti sotto custodia
americana in Iraq e Afghanistan a partire dal 2002, di cui almeno 34 sono
considerate omicidi “causati intenzionalmente o per comportamento imprudente”.
Altri undici casi sono considerati sospetti, e fra gli otto e i dodici prigionieri
sono stati torturati a morte. Il rapporto è stato realizzato con dati
provenienti da fonti ufficiali americane. Intanto in Iraq, con la bomba alla
cupola d'oro di uno dei più venerati mausolei sciiti in Iraq, quello
di Askariya a Samarra è andata in frantumi anche la speranza di un
dialogo tra le diverse etnie e ora si sta sciovando verso la guerra civile.
Vai al sito di unimondo
Guarda la video-inchiesta
di Rainews24
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Babilonia militare
Fabio Mini,
generale dell'esercito, già capo di Stato maggiore del comando Nato
delle forze alleate Sud Europa, ed ex comandante della missione Kfor in Kossovo.
Un altro attacco a Nassiriya ha
riportato l’attenzione dei media, del mondo politico e quindi dell’opinione
pubblica sulle nostre missioni militari all’estero. In questi tristi
frangenti ci sono ormai degli schemi di comunicazione e di reazione che sono
diventati dei veri e propri riti: paludati, commoventi, partecipati, ma fini
a se stessi. Aridi e sterili, dai quali non nasce nessuna presa di coscienza
e soprattutto nessuno scrupolo professionale e morale. C’è il
rito dell’esecrazione, della condanna dell’atto che per definizione
è sempre terroristico, efferato, vile e barbaro. E non può essere
altrimenti perché noi agiamo nel mito e con il rito della pace: non
facciamo la guerra, non andiamo nel luoghi di guerra, non offendiamo nessuno
e portiamo soltanto la pace, libertà e democrazia all’insegna
della bontà d’animo e della nostra superiore civiltà.
Questo rito rifiuta le ragioni degli altri, nega lo status di nemico a chi
ci offende e nega perfino cioò che il diritto internazionale stabilisce:
se si è n casa d’altri con le armi e si pretende di controllare
l’ordine e la sicurezza si è occupanti a prescindere dai motivi
o dalle intenzioni. Se si impiegano i contingenti armati e non si garantisce
né ordine né sicurezza non si è nulla.
Non esiste uno status internazionale
di liberatori o di samaritani armati. La presenza militare straniera su un
territorio soggetto a una sovranità locale non può essere lasciata
nel vuoto istituzionale o alla mercè delle pulsioni politiche di questo
o quel signorotto. La presenza militare istituzionale, cioè quella
espressa dagli Stati e non dalle compagnie di mercenari, ha una valenza particolare
proprio perché influisce sulla sovranità dello Stato, sulla
sua sicurezza e sulla indipendenza delle sue legittime e legali istituzioni.
Rispetto della sovranità e sicurezza sono i requisiti essenziali di
qualsiasi processo di pace, ordine e ricostruzione. Perciò il diritto
internazionale si sforza di contemplare i casi possibili di intervento armato
su territori esteri e di fissarne i limiti di legittimità, stabilendo
che la presenza di truppe straniere non sottrae mai la sovranità dello
stato ospitante. Tale presenza non può essere trattata in maniera ambigua
e indefinita neppure se si tratta di una partecipazione “tecnica”,
di semplice cooperazione o di un atto di solidarietà. Senza uno status
ben definito e senza l’accettazione corale e istituzionale del paese
ospitante, la presenza militare, specie se protratta nel tempo, rischia di
sconfinare nella prevaricazione e nella limitazione dela sovranità
altrui, rendendo legittima qualsiasi resistenza anche armata.
Le forze armate straniere che rifiutano
lo status di occupanti e che non chiariscono né gli scopi né
i limiti di tempo della loro presenza sul territorio altrui si pongono nelle
condizioni di non ottemperare né alle finalità della pace e
della sicurezza né a quelle della pacificazione e della ricostruzione,
che invece caratterizzano, contrariamente a quanto pensano molti politicanti
di casa nostra, i periodi di occupazione regolati dal diritto internazionale.
Con tale ambiguità si negano tutti i diritti (pochi ma essenziali)
e i doveri (molti e realmente umanitari) che le forze di occupazione hanno
nei riguardi della popolazione locale e viceversa. Ma, cosa ancora più
grave, si finisce per creare una situazione virtuale di non-guerra e di non-rischio
che porta a negare la necessità delle misure di sicurezza per le proprie
forze e per le popolazioni civili, a negare la presenza di un avversario legittimo
e a negare, come successo per il nostro Esercito, le risorse da assegnare
per preparare adeguatamente le forze e per condurre la missione di sicurezza
con il minimo dei rischi possibili. Infatti, il rito della pace virtuale non
prevede nemici legittimi da combattere con i mezzi e i procedimenti legittimi
della guerra, ma solo “criminali” da individuare e neutralizzare
con i mezzi e i procedimenti delle polizie, da un lato, o con il terrorismo,
dall’altro. Tutto ciò in un ambiente talmente ideologizzato da
far diventare criminali tutti coloro che non la pensano come te o che si vestono
e pregano in modo diverso, senza l’autorità necessaria, senza
il supporto di forze locali competenti e affidabili, senza conoscere il quadro
culturale e sociale e senza avere il vero controllo del territorio che, in
queste situazioni, non è il controllo dei confini, dei sassi e degli
incroci stradali, ma delle persone. Persone da capire e da conquistare con
la persuasione piuttosto che con la dominazione.
C’è poi il rito, mesto,
ma non meno subdolo, della consacrazione delle vittime e dei martiri. E’
il solo rito necessario, perché il sacrifico va riconosciuto e ai caduti
va reso omaggio, con rispetto e riconoscenza.
Anche il rito della consacrazione però è spesso fine a se stesso.
Non c’è nessuna analisi e riflessione morale e operativa. Le
ricompense alla memoria tardano, le inchieste si arenano e si tenta di consolare
i familiari delle vittime, di sollevare il morale di chi continua a rischiare
negli stessi posti e di far dimenticare presto lo spiacevole incidente a chi
sta in patria a guardare distratto la televisione con i soliti slogan: “Noi
abbiamo fatto il possibile”, “ Non dimenticheremo”, ”Non
cederemo”, ” Il sacrificio non sarà vano”, ”La
responsabilità è solo dei criminali”…
Martedì 2 maggio abbiamo seppellito le ultime vittime e consumato tutti
i riti previsti e già sappiamo che non cambierà nulla. Dell’inchiesta
subito avviata non si saprà più niente. Si continueranno a tacere
e minimizzare le centinaia di attacchi e le intimidazioni che ormai da tre
anni caratterizzano la “routine” dei nostri contingenti in Iraq.
Se venisse unificato il sistema di identificazione e valutazione degli “incidenti
operativi” e se essi venissero rapportati alla situazione politico-amministrativa
locale, a quella socio-economica, alla presenza delle forze di sicurezza,
alla natura della minaccia locale ed ai mezzi di cui dispongono sia i probabili
avversari, sia le forze della coalizione presenti e se si considerassero le
responsabilità politiche, militari e di comando e a quelle della guerra
avute dalle varie nazioni della coalizione, si potrebbe scoprire che gli attacchi
al nostro contingente sono statisticamente più intensi e pericolosi
e più efficaci degli stessi attacchi che vengono portati ai contingenti
inglesi e perfino americani. Di certo si scoprirebbe che essi delineano una
situazione in cui la priorità non è quella dei distribuire caramelle
o portare carrozzelle e neppure di addestrare ad esercitare il potere gente
che non ha i nostri stessi riferimenti né di democrazia, né
del diritto e neppure dei procedimenti e dell’etica della sicurezza.
Ci sarebbe una valutazione diversa non tanto sulle finalità quanto
sui traguardi da raggiungere nel campo della sicurezza, sui programmi concreti,
sui tempi e sui mezzi e sulle risorse da assegnare alla missione. Probabilmente
questo ultimo attacco non servirà neppure a chiarire le idee sul futuro
della missione a chi ha promesso agli elettori di ritirare i contingenti militari
e di sostituirli con agenzie civili di aiuto umanitario o con l’assegnazione
di fondi straordinari al governo iracheno. Sono proposte perfettamente in
linea con il film della pace virtuale già visto. Se non se ne modifica
la trama e non si sostituisce la regia, si finisce per avere lo stesso film
con protagonisti diversi.
Sulla questione dei fondi
c’è infine una considerazione interessante che viene da uno studio
di “Foreign Policy” sugli Stati falliti o in via di collasso.
Gli Stati più a rischio nonostante abbiano ricevuto la maggior quantità
di aiuti economici procapite sono nell’ordine: Congo, Iraq, Sierra Leone,
Afghanistan e Bosnia. Il Kosovo non è citato solo perché non
è considerato uno Stato, ma se lo fosse sarebbe in testa. Tutti questi
Stati non solo hanno ricevuto e continuano a ricevere aiuti economici rilevanti,
ma “ospitano” anche le più grandi e complesse operazioni
internazionali di cosiddetto peacekeeping e sono “teatri” di più
assidua proiezione del film della pace virtuale. Se nonostante la combinazione
di aiuti e operazioni militari questi paesi sono ancora in testa alla classifica
degli Stati in via di fallimento, occorre riflettere sulla vera natura delle
cause della loro situazione e agire su di esse piuttosto che tentare di smarcare
un impegno elettorale con l’ennesimo rito della foglia di fico.
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Iraq: e ora?
Nino Sergi,
Segretario generale di Intersos, pubblicato su www.vita.it, il 12/06/2006
(titolo originale «Il Governo ora metta a punto il programma di cooperazione»)>
Apprezziamo
la decisione italiana di rinunciare alla missione “civile-militare”
in Iraq. Il Governo deve ora mettere a punto il programma di cooperazione,
a livello politico, economico e umanitario, annunciato a Baghdad dal Ministro
degli Esteri D'Alema. Una cooperazione doverosa, che non dovrà sostituirsi
alle capacità irachene ma dovrà al contrario appoggiarle e valorizzarle:
l'Iraq non è infatti un paese sottosviluppato privo di competenze e
ingegnosità, al contrario possiede risorse umane, culturali, professionali
anche di alto valore.
Non potrà trattarsi,
come sempre d'altronde, di un programma “neutro”, perché
le scelte in esso contenute esprimeranno altrettante scelte politiche del
nostro Governo. E in questa occasione esso dovrà, a nostro avviso,
dimostrare di sapere scegliere con coraggio e con una ritrovata iniziativa
politica internazionale.
Intersos si è espressa
recentemente manifestando e motivando forti dubbi sull'intervento civile-militare.
La propria valutazione si basa sull'analisi politica e sull'esperienza acquisita
operando da tre anni in Iraq, senza interruzione. Riteniamo quindi
utile esprimere ora anche alcuni suggerimenti, quali contributo propositivo
alla definizione delle scelte politiche e delle priorità del programma
di cooperazione del Governo italiano con l'Iraq.
1. Rafforzare il multilateralismo
Il rafforzamento delle nuove istituzioni democratiche, della sicurezza e quindi
dello sviluppo infrastrutturale ed economico dell'Iraq potrà essere
efficace solo attraverso un'>iniziativa multilaterale, coordinata e
forte, di aiuto al paese. La cooperazione italiana, come ogni altra
cooperazione bilaterale, dovrebbe favorire tale iniziativa coordinando in
essa ogni azione volta al consolidamento delle istituzioni e al potenziamento
della sicurezza. La scelta multilaterale esprimerebbe anche una reale svolta,
dando priorità alla collaborazione tra stati rispetto alla prepotenza
unilaterale.
Le Agenzie dell'ONU non hanno mai smesso di essere attive in Iraq, direttamente
o tramite le ONG o altre entità operative, anche dopo l'attentato alla
loro sede a Baghdad nel 2003. Questa presenza operativa andrebbe quindi valorizzata,
contribuendo al contempo a rafforzare il ruolo politico dell'azione multilaterale
nel paese.
2. Rafforzare la presenza politica europea
L'Unione Europea può oggi, in presenza delle nuove Istituzioni irachene,
giocare un ruolo di primo piano, sia per il rafforzamento dell'azione multilaterale
che per la definizione delle linee strategiche da adottare per uscire dal
caos iracheno. La difficile situazione irachena riguarda ormai tutti e le
possibili soluzioni richiedono un'assunzione di responsabilità
da parte di tutti, compresa l'UE, finora troppo assente a causa delle
divisioni interne. Il Governo italiano dovrebbe aiutare l'Europa ad assumere
finalmente e senza più esitazioni le proprie responsabilità.
Per la ricostruzione dell'Iraq la cooperazione dell'Unione Europea, insieme
a quella delle Agenzie ONU, potrebbe rappresentare l'elemento chiave per il
necessario cambiamento.
3. Lasciare all'Iraq le sue ricchezze
La principale ricchezza dell'Iraq, dopo la sua popolazione che purtroppo viene
presentata prevalentemente legata alle violenze e al terrorismo, è
il petrolio. È stato uno dei motivi della guerra ed
è oggi uno dei maggiori elementi di divisione degli iracheni: dovrebbe
quindi essere tenuto presente anche nelle considerazioni per la definizione
dei rapporti di cooperazione. Se gli enormi profitti che ne possono derivare
vengono sottratti al Governo iracheno, come le grandi compagnie petrolifere
stanno cercando di fare, ogni altra azione di cooperazione e aiuto allo sviluppo
perderebbe significato e rappresenterebbe uno puro inganno.
Il Governo italiano potrebbe dare alla comunità internazionale uno
significativo segnale politico, invitando l'ENI, di cui è azionista
di maggioranza, a distanziarsi dal cartello delle compagnie petrolifere e
a definire con il Governo iracheno accordi basati sul riconoscimento
dei diritti degli iracheni e non su disposizioni speciali che moltiplicherebbero
i profitti delle compagnie straniere a detrimento della realtà locale.
Sarebbe anche il segnale di una nuova etica internazionale ed il seme per
un più equo ordine mondiale di cui il mondo ha estremo bisogno.
4. Sviluppare le organizzazioni della società civile
Il processo democratico dell'Iraq non può ridursi alle elezioni e alla
nascita di legittime istituzioni. Sostenere e sviluppare tale processo dovrà
anche significare aiutare la società civile a maturare politicamente dopo anni di dittatura, ad esprimere proposte, a partecipare alla vita democratica,
controllandola e difendendola. Significherebbe anche aiutare la formazione
del consenso, la costruzione di un “patto sociale” per la ricostruzione;
significherebbe favorire il dialogo tra le comunità e, in definitiva,
il rafforzamento della pace.
Numerose sono ormai le organizzazioni della società civile irachena.
Con alcune di esse esistono rapporti di collaborazione a livello internazionale,
compresa l'Italia: organizzazioni sindacali, sociali, culturali, professionali
ecc. Si tratta di una cooperazione che andrebbe prioritariamente tenuta in
considerazione nel definire il sostegno italiano al processo democratico dell'Iraq.
5. Sopperire alle necessità più sentite
Ogni cooperazione e aiuto allo sviluppo deve partire da bisogni reali. L'aiuto al Governo iracheno dovrà quindi essere indirizzato a rispondere
a tali bisogni. Se per l'Italia tale azione dovesse poi concentrarsi particolarmente
su Nassiriya e la provincia di Dhi Qar, ne risulterebbe un aiuto puntuale,
gradito alla popolazione. Contribuendo al soddisfacimento di tali bisogni
l'Italia diventerebbe agli occhi degli iracheni il paese amico e amato e darebbe
un segnale politico di nuova e diversa collocazione.
Ci sentiamo di suggerire alcuni bisogni prioritari, oltre a quelli ben conosciuti
e più volte evidenziati dell'elettricità e dell'acqua potabile.
- Assicurare la fornitura dei medicinali agli ospedali iracheni (la
sola Baghdad conta una quarantina di ospedali pubblici), oggi molto carente
e irregolare. Ai farmaci possono essere aggiunte le attrezzature degli istituti
ospedalieri e l'approfondimento scientifico del personale medico. Intersos
conosce particolarmente questa situazione dato il collegamento settimanale
di telemedicina con una realtà ospedaliera universitaria irachena.
- Assicurare l'assistenza umanitaria e il reinserimento agli
sfollati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni (15 mila famiglie
in pochi mesi) a causa del conflitto etnico-religioso che, anche se non dichiarato,
è già in atto e rischia di ampliarsi rapidamente.
- Assicurare il pieno funzionamento delle università.
Hanno tutte ripreso le attività con grande volontà di modernizzazione
culturale e scientifica. Le carenze finanziarie, scientifiche-professionali,
strutturali sono però molto pesanti e necessitano di aiuti immediati
e di apertura e collegamento con la comunità scientifica internazionale.
Più in generale, è l'intero sistema scolastico che necessiterebbe
un immediato forte sostegno.
- Assicurare la formazione dei pubblici amministratori, a
livello centrale e locale, per una corretta gestione dell'amministrazione
e dei servizi, per la loro modernizzazione sia in termini concettuali che
pratici, per creare la necessaria fiducia tra la gente e le istituzioni.
- Assicurare la tutela del patrimonio culturale. Si tratta
di un patrimonio inestimabile la cui perdita o il cui deterioramento rappresenterebbe
una gravissima privazione per l'Iraq, la sua cultura, la sua storia, la sua
identità nazionale.
La cooperazione
con l'Iraq non richiede una presenza permanente di personale civile.
Anche perché non potrebbe muoversi se non a rischio della propria vita
e comunque impegnando per la propria tutela, in modo improprio, personale
militare della rappresentanza diplomatica italiana. Le capacità di
potere assumere la propria ricostruzione sono già in Iraq e sono garantite
dagli iracheni. Occorre solo dare loro fiducia, aiutandole, valorizzandole,
coinvolgendole pienamente e facendole sentire attori del proprio futuro e
del proprio sviluppo. È proprio ciò che è mancato in
questi tre anni di “esportazione della democrazia” e che va ora
rapidamente attuato.
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Grandi manovre petrolifere per il bottino di guerra in Irak
di Fabio Alberti,
presidente ong Un ponte per.. www.osservatorioiraq.it 18 giugno 2006
La discussione, a cui stiamo assistendo in Italia, sui tempi e i modi del
ritiro delle truppe dall’Iraq rischia di riguardare più il posizionamento
dei partiti sul mercato italiano della politica che la sostanza delle cose.
Il movimento per la pace aveva chiesto un ritiro immediato, ma forse non ci
si poteva attendere tanto sulla base dei risultati elettorali e del contesto
internazionale.
La sostanza è, però, che l’Italia si ritira. Ciò
delegittimerà ulteriormente l’occupazione (anche se questo non
verrà mai dichiarato), costituisce un successo della mobilitazione
popolare contro la guerra (ed anche questo non sarà ammesso da nessuno)
e, soprattutto, permetterà se lo si vuole, di cambiare politica.
Il punto quindi è: quale nuova politica. E’ a questa che si deve
guardare per giudicare il significato politico del ritiro dette truppe, più
che ai tempi e ai modi.
Molti possono essere gli aspetti a cui guardare, ma il primo è il petrolio.
E’ questa una partita che si gioca a Baghdad nei prossimi mesi e condizionerà
lo sviluppo del paese per decenni. Il nuovo ministro iracheno del petrolio
Hussein al-Shahristani nel prendere incarico ha dichiarato (23 maggio) che
intende redigere al più presto la nuova legge sullo sfruttamento petrolifero
che “garantirà alle compagnie internazionali eque condizioni”.
USAID, la agenzia statunitense per gli aiuti allo sviluppo, sta fornendo “consulenza”
per la stesura del testo.
E’ noto che le imprese multinazionali del petrolio, che hanno finanziato
la elezione di Bush alla Casa Bianca, premono per una sostanziale modifica
della politica irachena sugli investimenti esteri nel settore petrolifero
(tradizionalmente caratterizzata da investimenti diretti dello stato e contratti
“di servizio” o di “sviluppo e produzione”con imprese
estere) affinché si adottino contratti a lungo termine più vantaggiosi
per loro, denominati “Production Sharing Agreement” (PSA).
Non c’è qui lo spazio per molti dettagli, basti sapere che i
PSA permettono alle imprese estere di iscrivere parte delle riserve petrolifere
irachene nei propri bilanci, con grande beneficio delle quotazioni di borsa
e di lucrare un maggior guadagno che può arrivare anche al raddoppio
rispetto alla normativa precedente la guerra. (Per approfondimenti si veda
il dossier “Truffa a mano armata”).
Contro questa ipotesi si sono pronunciati, con chiarezza, i sindacati dei
lavoratori del petrolio iracheni, che vedono nei PSA una svendita (o meglio
rapina) delle ricchezze nazionali.
Il cartello che le multinazionali del petrolio utilizzano in Iraq si chiama
International Tax & Investment Center (ITIC) ed ha tra i suoi fini statutari
“consigliare ai governi politiche fiscali e economiche appropriate”.
L’ITIC ha pubblicato nel novembre 2004 lo studio Petroleum and Iraq's
Future: Fiscal Options and Challenges per sostenere che la adozione dei PSA
“costituirebbe il miglior incentivo per spingere le imprese estere ad
investire in Iraq”. L’ENI è tra i membri fondatori dell’ITIC,
con Shell, Total, Halliburton, Chevron e BP. Alla presentazione del documento
al governo iracheno erano presenti due manager dell’ENI: Roberto D’Amico
e Ferdinando Cazzini.
L’ENI, la maggiore impresa petrolifera italiana, pubblica (e cioè
nostra) per il 32%, è dunque della partita. E’ noto che ha una
prelazione per la concessione dei giacimenti di Nassiriya inoltre, proprio
la settimana scorsa, l'amministratore delegato Paolo Scaroni ha dichiarato
l’interesse dell’azienda per lo sfruttamento del petrolio nella
zona del Kurdistan.
E’ stato stimato che i maggiori profitti che l’ENI avrebbe da
un contratto di PSA per il giacimento di Nassiriya potrebbero raggiungere
i 6 miliardi di euro, che costituirebbero quindi un “dividendo di guerra”,
e che è una cifra enormemente superiore agli aiuti umanitari che l’Italia
potrebbe inviare.
Una diversa politica in questo settore dovrebbe vedere da parte italiana la
rottura del cartello delle imprese petrolifere (abbandonando o prendendo le
distanze dalle proposte dell’ITIC) e la dichiarazione di disponibilità
a trattative separate sulla base delle condizioni che l’Iraq proponeva
prima della guerra.
Se non si andasse in questa direzione si darebbe l’impressione che,
nonostante il ritiro delle truppe, l’Italia intenda ugualmente lucrare
sulle condizioni di miglior favore per le multinazionali del petrolio che
si sono determinate a seguito della guerra.
Una politica di “commercio equo” nel petrolio rafforzerebbe invece
quanti in Iraq si battono per evitare la svendita delle ricchezze nazionali,
contribuirebbe all’indipendenza e alla ricostruzione del paese in misura
ben superiore agli aiuti umanitari di cui si parla in questi giorni. In un
certo senso si tratta di recuperare, aggiornandola, la politica di Enrico
Mattei.
Se si ritirassero le truppe, anche immediatamente, e si facesse una politica
di rapina economica davvero non sarebbe cambiato molto.
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Nassiria, pozzo senza fondo
Di Gianluca Di Feo, L’espresso, 11 maggio 2006
Abbiamo speso più per gli 007 che per gli aiuti. È il paradosso
più grande della missione italiana in Iraq, una spedizione nata per
favorire la ricostruzione del Paese dopo gli anni della dittatura di Saddam
Hussein e soprattutto per dare sollievo alla popolazione stremata da embargo
e combattimenti. Doveva essere una missione umanitaria: invece a Nassiriya
l'Italia ha investito più negli agenti segreti che nel sostegno agli
iracheni. Nei primi sei mesi del 2006 il bilancio approvato dal governo per
l'operazione Antica Babilonia prevede 4 milioni di euro di aiuti e ben 7 milioni
"per le attività di informazioni e sicurezza della presidenza
del Consiglio dei ministri", ossia per gli inviati del Sismi. E la stessa
cosa è avvenuta sin dall'inizio: in tre anni l'intelligence ha ottenuto
circa 30 milioni di euro mentre per "le esigenze di prima necessità
della popolazione locale" ne sono stati stanziati 16. Un divario inspiegabile,
che sembra mostrare l'Italia più interessata allo spionaggio che al
soccorso di quei bambini per i quali era stata decisa la partenza di un contingente
senza precedenti: oltre 3.500 militari con mille veicoli.
Ma a leggere i dati contenuti
nella monumentale relazione pubblicata sul sito dello Stato maggiore della
Difesa, tutta l'operazione Antica Babilonia appare come una voragine, che
inghiotte finanziamenti record distribuendo pochissimi aiuti. O meglio, i
conti mettono a nudo la realtà che si vive a Nassiriya: non è
una missione di pace, ma una spedizione in zona di guerra. Finora infatti
sono stati stanziati 1.534 milioni di euro, poco meno di 3 mila miliardi di
vecchie lire, per consegnare alla popolazione della provincia di Dhi-Qar poco
più 16 milioni di materiale finanziato dal governo: un rapporto di
cento a uno tra il costo del dispositivo militare e i beni distribuiti. In
realtà, però, la spesa totale per le forze armate italiane a
Nassiriya è addirittura superiore a questa cifra: tra stipendi, mezzi
distrutti ed equipaggiamenti logorati dal deserto la cifra globale calcolata
da 'L'espresso', consultando alcuni esperti del settore, si avvicina ai 1.900
milioni di euro.
Intelligence a
go-go
Su tutte le pagine del rapporto dello Stato maggiore Difesa,
disponibile sul sito web, è stampata la dicitura: 'Il presente documento
può circolare senza restrizioni'. Solo nelle ultime 20 pagine questo
timbro non compare. Ed è proprio nella nota finale sugli aspetti finanziari
di Antica Babilonia che compaiono le notizie più delicate. A partire
dalla voce: 'Attività di informazioni e sicurezza della PCM', ossia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta dei fondi extra consegnati
agli agenti del Sismi che operano in Iraq: non si sa se lo Stato maggiore
li abbia indicati per voto di trasparenza, per errore o per una piccola mossa
perfida. Di fatto, finora le disponibilità degli 007 erano un mistero,
oggetto di grandi illazioni soprattutto per quanto riguarda la gestione dei
sequestri di persona. Da anni si discute delle riserve usate dalla nostra
intelligence per comprare informatori o per eventuali riscatti pagati durante
i rapimenti. Adesso queste cifre permettono di farsi qualche idea del costo
dei nostri 007 in azione. Per i primi sei mesi del 2003, purtroppo, lo Stato
maggiore non è illuminante: la provvista è mescolata assieme
alle spese di telecomunicazioni, quelle dei materiali per la guerra chimica
e quella per il trasloco delle truppe. In totale poco meno di 35 milioni.
Facendo il confronto con i bilanci dei semestri successivi, si potrebbe ipotizzare
che al Sismi siano andati circa 4 milioni di euro. In ogni caso, gli stanziamenti
diventano poi espliciti: 9 milioni nel 2004, 10 milioni nel 2005, 7 milioni
già disponibili per i primi sei mesi di quest'anno. Una somma compresa
tra i 50 e i 60 miliardi di vecchie lire, destinata soltanto a coprire i sovrapprezzi
delle missioni top secret in territorio iracheno, a ricompensare gli informatori
e, verosimilmente, alla gestione dei sequestri di persona. Quelle operazioni
che hanno determinato il ritorno a casa di sei ostaggi, grazie anche al sacrificio
del dirigente del Sismi Nicola Calipari. Un ultimo dato: dalla stessa relazione
dello Stato maggiore apprendiamo che il Sismi ha avuto altri 23 milioni e
mezzo per la missione in Afghanistan. Anche in questo caso, la dote degli
007 supera di gran lunga il valore dei beni distribuiti alla popolazione.
La lontananza
è cara
Le voci trasporti e telecomunicazioni della spedizione
hanno importi choc. Per i viaggi avanti e indietro dei reparti, dei rifornimenti
e degli equipaggiamenti, sono stati spesi finora 125 milioni di euro. Ogni
quattro mesi infatti le brigate impegnate a Nassiriya vengono sostituite:
devono tornare in Italia con le loro dotazioni di materiali e armi leggere.
Veicoli e scorte invece restano sempre in Iraq, salvo quando il logoramento
impone di rimpiazzarli. Sorprendente anche la 'bolletta del telefono': 11
milioni in 18 mesi. Non si tratta delle chiamate a casa dei soldati o dei
carabinieri, ma del flusso di telecomunicazioni via satellite per l'attività
dei militari: i contatti con l'Italia, quelli con i comandi alleati e molte
delle trasmissioni radio sul campo. Pesante pure il capitolo 'Croce rossa
italiana': si tratta di oltre 32 milioni di euro. E riguardano il solo ospedale
di Nassiriya, quello che fornisce assistenza medica ai nostri militari. Questa
struttura ha soltanto come scopo secondario l'attività in favore della
popolazione locale: 450 ricoveri in tre anni. Nel 2003 la Croce rossa aveva
a Nassiriya 85 persone, poi scese a 70: dall'inizio della missione si tratta
di una spesa media per ogni operatore sanitario di oltre 400 mila euro. Perché?
La risposta ufficiale chiama in causa le indennità straordinarie e
le difficoltà di trasferire medicinali e apparecchiature. L'ospedale
da campo creato a Baghdad nel 2003, invece, era finanziato con i fondi del
ministero degli Esteri: il costo era ancora più alto, ma i pazienti
erano tutti iracheni.
Farnesina tecnologica
La quota più consistente dei fondi destinati alla rinascita
dell'Iraq viene gestita dalla Farnesina: 103 milioni di euro. La fetta maggiore
è stata inghiottita dall'ospedale di Baghdad e dalla difesa dell'ambasciata.
Ci sono poi numerose iniziative ad alta tecnologia, tutte realizzate in Italia
e alcune di discutibile utilità: 5 milioni per la rete telematica Govnet
che dovrebbe connettere i ministeri di Bagdad; 800 mila euro per la ricostruzione
virtuale in 3D del museo di Bagdad. I programmi di formazione invece prevedono
che il personale iracheno frequenti dei corsi in Italia: una procedura sensata
quando si tratta di lezioni per dirigenti o tecnici di alto livello, forse
meno quando comporta il trasferimento a Roma di 30 orfani destinati a imparare
il mestiere di falegname, barbiere o sarto. Più concreti gli interventi
gestiti dal Ministero attraverso la Cooperazione per la ricostruzione dell'agricoltura,
del sistema scolastico e di quello ospedaliero: ma nei primi 18 mesi nella
regione di Nassiriya erano stati realizzati progetti per soli 3,7 milioni.
Armata ad alto
costo
Tra aiuti diretti consegnati dai militari e progetti, concreti
o virtuali, della Farnesina in tutto sono stati stanziati 119 milioni di euro.
Secondo lo Stato maggiore, per il contingente armato finora sono stati messi
a disposizione 1.418 milioni di euro. Ma è un stima parziale: non tiene
conto del costo degli stipendi, del logoramento dei mezzi, di molte delle
parti di ricambio. Non tiene conto dell'elicottero distrutto in missione,
dei dieci veicoli Vm90 annientati negli attacchi, delle munizioni esplose,
della base dei carabinieri cancellata dall'attentato del 2003. Non tiene conto
del terribile bilancio di vite umane: 22 tra carabinieri e soldati caduti
e 61 feriti in azione, altri sette morti e sette feriti in incidenti. In più
un civile ammazzato nella strage del 12 novembre 2003 e un altro ferito. Un
sacrificio giustificato dai risultati? Di sicuro, non si può chiamarla
una missione di pace. Nei quattro mesi 'più tranquilli' i parà
della Folgore hanno distribuito beni o avviato progetti pari a 4 milioni di
euro, finanziati dal governo o da istituzioni e aziende italiane: in più
hanno vigilato sulla nascita di iniziative internazionali per altri 6 milioni
di dollari. Nella fase di crisi della battaglia dei ponti, invece la brigata
Pozzuolo del Friuli si è fermata a meno di 4 milioni di dollari tra
attività portate a termine o soltanto avviate. Ormai è difficile
anche controllare a che punto sono i lavori nei cantieri: ogni sortita è
pericolosa. Per questo il comando di Nassiriya ha ipotizzato di usare gli
aerei-spia senza pilota, i Predator, che con le telecamere all'infrarosso
possono verificare se i macchinari sono accesi o se i manovali ingaggiati
dalla Cooperazione stanno perdendo tempo. Certo, si potrebbe affidare la sorveglianza
alle autorità irachene: grazie a un programma della Nato abbiamo addestrato
2.600 soldati e 12 mila poliziotti locali. Eppure tanti uomini in divisa non
sono bastati a impedire che un'imboscata venisse messa a segno a pochi metri
dal commissariato più importante.
Aiuti oltre i
limiti
Soldati e carabinieri escono ancora dalla loro base per sostenere
la popolazione. Prima della strage del 2003 lo facevano molto di più:
fino a quel momento la brigata Sassari aveva percorso un milione e 900 mila
chilometri; dopo di loro i bersaglieri della Pozzuolo del Friuli ne hanno
macinati solo 460 mila. C'è un dato che fotografa la situazione meglio
di ogni altra analisi: poco meno di 2 milioni di chilometri totalizzati dalle
colonne dell'Esercito in quattro mesi prima dell'attentato, altrettanti percorsi
nei 24 mesi successivi. Eppure, nonostante i rischi altissimi testimoniati
dall'attacco costato la vita a due carabinieri e un capitano dell'Esercito,
i nostri militari non rinunciano a condurre le attività umanitarie.
Cercano di costruire scuole e ambulatori, forniscono macchine ai laboratori
artigianali e all'unica raffineria. Per evitare imboscate, lo fanno di sorpresa:
arrivano nei villaggi all'improvviso, scaricano doni e materiali, poi ripartono.
Se invece c'è qualche cerimonia ufficiale, tutta l'area viene presidiata
in anticipo con cecchini e blindati. Insomma: una situazione di guerra. Ma
nessuno si sottrae ai pericoli. Anzi, tutti i reparti fanno più del
necessario. Prima di partire per l'Iraq, c'è una sorta di questua tra
istituzioni locali e aziende della zona dove ha sede la brigata per raccogliere
aiuti da distribuire: spesso i reparti mettono insieme una quantità
di merci superiore ai fondi governativi. Inoltre in occasioni particolari,
ci sono collette tra i soldati per acquistare riso o medicinali. O iniziative
straordinarie, come quella della famiglia del maresciallo Coletta, una delle
vittime del la strage del novembre 2003, che ha mandato un container di farmaci
per un ospedale pediatrico. Ma a tre anni dalla caduta di Saddam ha ancora
senso rischiare la vita di 20 militari per consegnare un camion di riso e
medicine?
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Un'ipotesi per il ritiro dall'Iraq
Gianni Rufini,Gianni
Rufini, Università di York - Post-war Reconstruction and Development
Unit lunedì 29 maggio 2006. Scritto per Lettera 22 su www.socialpress.it
Non giochiamo
a fare previsioni su questo Iraq. Certo non assomiglia al Kosovo del 1999
né al Mozambico del 1991, ma piuttosto alla Somalia del 1993, il primo
grande fallimento di una missione internazionale. Con l’ultima riunione,
il Governo sembra aver intrapreso la strada virtuosa del ritiro totale, senza
la foglia di fico della “missione civile” scortata da mille soldati,
come in un primo momento si era paventato. Ma saranno molte le pressioni,
nelle prossime settimane, per ritornare sulla decisione presa. A parte i soliti
guerrafondai, molti obietteranno che così facendo, l’Italia uscirebbe
di scena e perderebbe l’occasione di giocare un ruolo nel processo di
ricostruzione iracheno. Cerchiamo allora di capire come si potrebbe mantenere
un ruolo rilevante nella transizione irachena, senza compromettersi militarmente.
Gli iracheni e l’Occidente
La prima cosa importante è che si capisca fino in fondo che qui i problemi
tecnici e politici si mescolano irrimediabilmente con i simboli, e con i sentimenti
degli iracheni: una presenza militare - sia pure simbolica - sarà sempre
vista come un’occupazione. Non è il caso di addentrarci nei meandri
del diritto internazionale (che pure parla chiaro), il problema è di
percezione. Gli stranieri in Iraq, in particolare gli occidentali, erano visti
come nemici anche prima della guerra, per via del conflitto precedente e,
soprattutto, delle sanzioni, che avevano fatto precipitare il livello della
qualità della vita nel paese. Ne sanno qualcosa le ONG e le agenzie
ONU che ci hanno lavorato tra il 1992 e il 2003. Oggi, anche gli iracheni
filo-occidentali, anche i più democratici e liberali riconoscono che
lo stato d’occupazione (formale o no) è il grande fattore di
destabilizzazione del paese. L’ostilità verso l’Occidente,
nelle sue molte sfumature, è comunque universale, ed è un tratto
ormai strutturale della società irachena. Ci vorranno decenni per superarlo,
e la manifestazione più odiosa per l’opinione pubblica è
costituita proprio la presenza militare.
La missione di pace italiana
Gli italiani, in “missione di pace”, si sono presentati al seguito
delle truppe d’occupazione, senza alcun mandato delle Nazioni Unite.
Ospiti non invitati, ingombranti e armati fino ai denti, non sono stati certo
riscattati da un tardivo mandato del Consiglio di Sicurezza, che in realtà
ha preso atto dello status quo, ricordando alle forze occupanti l’obbligo
giuridico di amministrare il paese occupato. A conti fatti, la risoluzione
dell’ONU ha in sostanza formalizzato l’integrazione dell’Italia
nella Coalizione. E in ogni caso, agli occhi degli iracheni, non basta essere
più simpatici per distinguersi da tutti gli altri che hanno fatto la
guerra e invaso il paese. D’altronde tutto questo si sapeva già.
Basta ricordare quello che era avvenuto in Somalia nel 1992-93, quando le
Nazioni Unite avevano inviato nel paese la missione Restore Hope, col compito
di fermare la guerra tra i warlords e assistere la popolazione stremata. La
spedizione fu accolta con entusiasmo dalla popolazione, ma dopo qualche mese
gli USA pretesero ed ottennero dall’ONU una seconda missione, parallela
alla prima, la UNITAF, con compiti di polizia per arrestare e neutralizzare
il gen. Aidid, presunto colpevole di tutto il caos somalo. UNITAF usava la
mano pesante: arresti arbitrari, perquisizioni a tappeto, scontri a fuoco,
uso della tortura negli interrogatori, ecc. I somali non distinsero più
tra le due missioni internazionali, per loro tutti gli stranieri erano diventati
ugualmente dei nemici, e si ribellarono. Restore Hope fallì miseramente,
molti uomini vennero uccisi e il paese fu infine abbandonato a se stesso.
Non basta dichiararsi buoni, bisogna anche sembrarlo. Ed essere creduti.
Militari e civili
Si è parlato molto di un intervento civile per la ricostruzione, che
dovrebbe però essere protetto dalle forze militari, “almeno 800
uomini” secondo la Difesa. Innanzitutto bisogna chiedersi a quale scopo
mandare dei civili in Iraq. I bisogni prioritari del paese in termini di ricostruzione,
sono chiari: il sistema sanitario, le scuole, l’acqua e i servizi igienici,
l’agricoltura e le piccole attività produttive, strade e infrastrutture
urbane. Insomma, tutte cose banali, ampiamente alla portata degli iracheni
stessi: non bisogna dimenticare che l’Iraq ha avuto per quarant’anni
il miglior sistema scolastico e universitario del Medio Oriente. E allora
perché dovremmo mandare esperti italiani, a 20-30mila euro al mese,
quando con la stessa cifra si potrebbero assumere decine e decine di ottimi
tecnici locali? E perché dovremmo schierare centinaia di costosissimi
soldati a difenderli, quando i bravi iracheni potrebbero tranquillamente farne
a meno? Chiunque sappia qualcosa di cooperazione e di aiuto umanitario sa
benissimo che non solo mandare tecnici italiani è inutile, ma anche
che semplicemente non è possibile lavorare circondati dai blindati,
sorvolati dagli elicotteri e con i cecchini piazzati sui tetti delle case.
Certo, possono esserci settori particolari, come la conservatoria dei musei
o l’archeologia, dove un qualche apporto di competenza italiana potrebbe
risultare utile, ma a quale prezzo?
Imparare dall’Afghanistan
Si è parlato molto di dispiegare nel paese i Provincial Reconstruction
Teams (PRT) già sperimentati in Afghanistan. Si tratta di formazioni
miste militari-civili sotto comando militare, che si impegnano in quel tipo
di operazioni sopra descritte, che rendono mostruosamente costosi e pericolosi
dei banalissimi lavori edili o la distribuzione di aiuti di base. E’
come se l’idraulico si presentasse a casa vostra protetto da una decina
di guardaspalle che per proteggerlo si piazzano in salotto, in bagno e in
camera da letto, mettono faccia al muro vostro figlio e vostra moglie, puntano
il mitra sui vicini di pianerottolo e sequestrano l’ascensore. In Afghanistan,
i PRT hanno definitivamente compromesso la credibilità degli operatori
civili, che subiscono continui attacchi, e perpetuano negli abitanti la sensazione
di avere il nemico in casa. D’altra parte, ben pochi negano che l’intera
operazione afgana sia un fallimento: Bin Laden sghignazza, i warlords si sono
ripresi il paese, i Taleban controllano saldamente un terzo del territorio,
il traffico di oppio è in pieno boom, le donne girano in burqa e il
paese è ridotto alla disperazione. Eppure sono passati cinque anni...
Che
fare
Se l’Italia vuole davvero giocare un ruolo in Iraq, allora deve cominciare
a pensare a come spende i soldi, dirottandoli dalle costosissime operazioni
militari verso le attività di assistenza e ricostruzione. Affidarsi
alle Nazioni Unite, alle ONG e al sistema imprenditoriale per attivare le
forze civili e le imprese locali, senza mettere a repentaglio la sicurezza
di soldati e tecnici. Dal 2004, per esempio, tutte le ONG internazionali hanno
ritirato i propri cooperanti dal paese e dirigono le operazioni da Amman o
da Kuwait City, contando sul personale iracheno per l’esecuzione dei
lavori, e recandosi ogni tanto in Iraq, per controllare come vanno le cose.
Rischi minimizzati, spese bassissime e risultati più che soddisfacenti.
Bisogna poi proseguire ed intensificare l’impegno per dotare il paese
di una forza di sicurezza ben addestrata, ben armata e adeguatamente formata
al rispetto dei diritti dell’uomo. Due assi strategici su cui impegnarsi
per un decennio, con certezza di risorse e rispetto degli impegni. Lavorando
con coerenza e continuità su questi due aspetti, l’Italia potrebbe
diventare veramente una protagonista della ricostruzione irachena, e un modello
di cooperazione internazionale.
Torna a inizio pagina

|
|
| |
In
Iraq la guerriglia spara con pistole italiane -
La Stampa, 24 Febbraio 2006
Quarantamila pistole della polizia italiana, rivendute dal ministero dell'Interno
alla Beretta, che ne avrebbe fatte arrivare «più della metà
in Iraq con una triangolazione: armi che sono finite anche nelle mani della
guerriglia.
Secondo la procura di Brescia questa operazione è stata realizzata
violando la legge.
Ma ora una norma inserita dal governo nel decreto sulle Olimpiadi di Torino
potrebbe cancellare l'inchiesta,salvando così l'azienda guidata da
Ugo Gussalli Beretta, amico personale del premier Berlusconi e della famiglia
Bush».
E' il settimanale l'Espresso a ricostruire la complessa vicenda di una partita
di 44.926 pistole «Beretta 92S», che il Viminale avrebbe ritirato
dal servizio tre anni fa per sostituirle con armi più moderne.
«Nel febbraio 2003 - scrive il settimanale - il ministero dell'Interno
cede alla fabbrica bresciana 44.926 pistole Beretta 92S: sono quelle delle
prime serie prodotte tra il 1978 e il 1980, ritirate dal servizio per essere
sostituite con armi più moderne.
Nonostante siano definite "fuori uso" si tratta di pistole semiautomatiche
ancora molto apprezzate sul mercato: armi di calibro nove parabellum, considerate
da guerra».
Secondo quanto ricostruito dall'Espresso, «gran parte delle pistole
era in buone condizioni ma venne svenduta dal ministero a prezzo di rottame.
Poi la fabbrica bresciana le ha rimesse a posto, rivendendole. Secondo i magistrati
di Brescia, posizione poi confermata dal Tribunale del Riesame, "la stessa
cessione delle armi da parte del ministero dell'Interno appare illegale":
non è stata rispettata la legge che impone il parere del ministero
della Difesa sulla vendita di armi da guerra.
Inoltre la Beretta dal 2002 non ha più la licenza per riparare armi».
Nel 2004 l'azienda bresciana «chiede la licenza per vendere armi al
governo provvisorio di Baghdad: la necessità di costruire l'arsenale
per il nuovo esercito e la nuova polizia irachena rappresenta per la Beretta
un'occasione unica di business. Ma - scrive il settimanale - , di fronte alle
richieste di chiarimenti da parte del ministero, rinuncia.
Contemporaneamente però chiede alla prefettura di Brescia il permesso
di vendere le Beretta della polizia italiana a una celebre ditta britannica,
uno dei colossi del commercio bellico internazionale, ottenendo il via libera.
In realtà tutte le 44.926 pistole sono già state pagate da un'altra
ditta: la Super Vision International ltd, una sigla inglese sconosciuta».
«Il primo stock di 20.318 pezzi viene consegnato nel luglio 2004. Ma
queste armi - sottolinea l'Espresso - finiscono in Iraq».
Nel febbraio dello scorso anno «i carabinieri del comando di stanza
in Iraq comunicano che "alcune pistole Beretta 92s sono state rinvenute
in possesso di forze ostili". E che le armi trovate nelle mani dei guerriglieri
"risultano vendute tra il 1978 e il 1980 al ministero dell'Interno italiano".
Le indagini - continua il settimanale - fanno scoprire l'incredibile triangolazione
e la magistratura sequestra nei depositi della Beretta le restanti 15.478
pistole già acquistate dalla misteriosa società britannica».
E ancora: «L'azienda reagisce e si difende con ostinazione. Davanti
al Tribunale del Riesame sostiene che avendo la licenza per fabbricare armi
poteva anche ripararle e rivenderle; che quelle pistole non potevano essere
considerate da guerra».
«I giudici - conclude l'Espresso - le danno torto su tutta la linea.
Ma il decreto sulle Olimpiadi di Torino approvato lo scorso 8 febbraio apre
uno spiraglio per il colosso bresciano, guidato da Ugo Gussalli Beretta».
In due righe del decreto, infatti, i fabbricanti di armi sono autorizzati
"alla riparazione delle armi prodotte" e "alle attività
commerciali connesse".
Dopo le anticipazioni dell'Espresso, Paolo Cento, coordinatore dei Verdi,
ha chiesto che Berlusconi e Pisanu riferiscano subito della vicenda in Parlamento:
«Da una parte fanno la guerra - ha detto -, dall'altra vendono armi
alla guerriglia. Ci sono molte zone d'ombra».
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Football e pizza - Così gli USA si preparano a restare in Iraq
di Oliver Poole dalla
base aerea di al-Asad -The Daily Telegraph, 11 febbraio 2006
Tratto da http://www.osservatorioiraq.it - data: 16/2/2006
La base aerea di al-Asad è
il più grande campo dei Marine nella provincia occidentale di Anbar.
Si trova nel mezzo della regione più ribelle dell’Iraq, dove
migliaia di rivoltosi sono stati uccisi in una serie di operazioni nel corso
dello scorso anno.
Ma entrate "all’interno"
e questa fascia di deserto somiglia sempre di più a una fetta delle
zone periferiche residenziali Usa piuttosto che alla prima linea di una zona
di guerra.
Fra i suoi ristoranti
ci sono un Subway e una pizzeria-fast food. C’è un coffee shop,
un’area per il football, e perfino una piscina.
Un cinema proietta
gli ultimi film, mentre il principale centro ricreativo del campo offre serate
danzanti speciali - hip hop il venerdì, salsa il sabato, e country
& western la domenica.
C’è
perfino un noleggio auto Hertz che fornisce macchine con finestrini anti-proiettile
per coloro che volessero attraversare la base in qualcosa di più comodo
di un Humvee militare.
Perché, mentre
le notizie da Washington si concentrano sul ritiro delle truppe, le forze
armate Usa stanno cominciando a mettere in atto con costi enormi la prossima
fase della loro politica per l’Iraq. Ed è una fase che probabilmente
deluderà quelli che sperano in una uscita rapida di tutte le truppe
straniere.
L’estate scorsa
sono cominciate a emergere informazioni secondo cui erano stati redatti piani
per creare quattro "super-basi", campi giganteschi che avrebbero
ospitato decine di migliaia di soldati Usa, simili ad altre strutture militari
estese in modo irregolare in tutto il mondo.
L’intenzione era
che l’esercito iracheno addestrato ed equipaggiato di fresco prendesse
in carico gradualmente la maggioranza delle operazioni di combattimento, consentendo
a una parte dei 138.000 soldati Usa di andarsene. Quelli rimasti avrebbero
fornito appoggio dai loro nuovi centri operativi quando fosse stato loro richiesto.
Questo passaggio
di consegne è già iniziato, con una dozzina di basi minori evacuate
nelle ultime settimane. In totale, c’è in programma di trasferirne
100 al governo iracheno quest’anno.
Anche se non verrà
data alcuna conferma ufficiale di dove saranno ubicate le super-basi, ad al-Asad
c’è tutta l’impressione che se ne stia creando una.
Le regole in base
alle quali ai giornalisti è consentito visitare le strutture militari
vietano qualsiasi accenno alla loro ubicazione, dimensione, o numero di truppe.
Ma non si vìola
alcuna regola a dire che questo è un posto così vasto che ha
al suo interno due linee di autobus e che la vista degli operai che stanno
costruendo nuovi alloggi per altri soldati è comune.
Il mese scorso, cartelli
rossi di "Stop" – l’elemento onnipresente dell’arredo
stradale americano – sono comparsi a tutti gli svincoli stradali.
Membri importanti
dei partiti sciiti al governo si sono lamentati del fatto che essi denotano
progetti americani per una presenza a lungo termine nel loro paese.
Alcuni membri sunniti
dell’Iraqi Islamic Party li considerano prova di una “occupazione”
indefinita, una accusa negata dai funzionari Usa, che insistono che le basi
sono un altro passo in un ritiro finale.
Ma perfino i Marine
di stanza ad al-Asad sono scettici su quanto rapidamente sarà completato
questo passo.
Si ritiene che all’esercito
iracheno manchi “almeno” un anno prima di essere in grado di combattere
i ribelli.
Alti ufficiali fanno
notare che quando la principale base dell’esercito vicino Tikrit è
stata consegnata alle forze irachene, un trasferimento molto pubblicizzato
da Washington come prova della capacità crescente dell’Iraq di
essere autosufficiente, essa è stata spogliata di tutto in poche settimane
dalle stesse unità irachene che avrebbero dovuto proteggerla.
Soprattutto c’è la
consapevolezza, acquisita attraverso una triste esperienza, che le previsioni
su che cosa sarà l’Iraq nel futuro immediato sono quasi sempre
sbagliate.
Al Colonnello H R McMaster,
il comandante delle truppe a Tal Afar, e l’alto ufficiale Usa le cui
tattiche di contro-guerriglia sono state lodate in modo particolare a Washington
e a Londra, è stato chiesto di recente che cosa pensava che i prossimi
12 mesi avessero in serbo per gli iracheni.
Ha rifiutato di
fare congetture. “Chiunque sostenga di capire che cosa sta succedendo
in Iraq non lo capisce", ha risposto.
Nel frattempo, i
militari prevedono con sicurezza che si avvicenderanno a rotazione nella base
per almeno un decennio.
Un sergente fa notare
che almeno potranno comprare una tazza di caffè degna di questo nome.
(Traduzione di Ornella
Sangiovanni)
Torna a inizio pagina

|
|
| |
Il destino dell'Iraq
di Tarik Ali (traduzione italiana adi Alessandro Siclari per NuoviMondiMedia, Tariq
Ali The Guardian, 16 gennaio 2006)
In Iraq
una preoccupazione tra i molti cittadini della nazione – compresi quelli
che inizialmente sostenevano la guerra – è quella di sapere se
il loro paese sopravviverà alla ricolonizzazione occidentale o se invece
questa condurrà alla disintegrazione del paese. Uno scenario hobbesiano
oggi potrebbe lasciare il posto a una soluzione di divisione in tre parti
domani.
Nell’ultima
metà del secolo scorso, il grande poeta iracheno Muhammad Mahdi al
Jawahiri – egli stesso figlio di un membro del clero sciita e nato nella
città santa di Najaf – esprimeva il suo distacco dal settarismo
religioso e affermava la sua fede nel nazionalismo iracheno: "Ana al
Iraqu, lisani qalbuhu, wa dami furatuhu, wa kiyani minh ashtaru" ( Io
sono l’Iraq, il suo cuore è la mia lingua, il mio sangue il suo
Eufrate, il mio intero essere è nato dalle sue ramificazioni). Da allora
sembra essere passata un’eternità.
Cosa dobbiamo
aspettarci oggi? L’occupazione statunitense è profondamente dipendente
dal supporto de facto dei gruppi sciiti, specialmente dello Sciri (il consiglio
supremo per la rivoluzione irachena), lo strumento di Teheran in Iraq. L'Ayatollah
Sistani subito dopo la caduta di Baghdad disse a tutti gli iracheni che auspicava
un Iraq unito e indipendente. Magari poteva davvero volerlo allora, ma oggi
le cose sono cambiate. Quando Sistani impedì ai gruppi sciiti di combattere
la loro battaglia e persuase Moqtada al Sadr di far cessare la resistenza,
stava anche intaccando l’unità della nazione. Una resistenza
unita che combatteva su due fronti avrebbe potuto portare a un governo unito
in un secondo momento. Non sorprende che Thomas Friedman, del New York Times,
abbia chiesto che Sistani fosse ricompensato con il premio Nobel per la pace.
Se i gruppi
sciiti avessero deciso di resistere all’occupazione, essa sarebbe finita
molto tempo fa, o addirittura non si sarebbe mai verificata. I gruppi clericali
al potere in Iran resero chiaro a Washington che non si sarebbero opposti
alla caduta di Saddam Hussein o a quella dei Talebani. Lo fecero, evidentemente,
perché era nei loro interessi e per motivazioni tutte loro, ma il loro
è stato un gioco pericoloso. Se i sunniti e i nazionalisti non avessero
resistito, negando a Bush e a Blair la gloria nella quale speravano, e creando
una crisi di fiducia nei confronti di Washington e Londra, il cambio di regime
a Teheran sarebbe rimasto in agenda, nonostante il sostegno iraniano agli
Usa.
Abbastanza
ironicamente, è stata la resistenza in Iraq che ha reso questa ulteriore
avventura impossibile nel medio termine. L’alto comando dell’esercito
americano, in grosse difficoltà in Iraq, è seriamente diviso
sulla guerra, e ci sono pochi dubbi sul fatto che alcune importanti figure
al Pentagono siano a favore di un rapido ritiro per pure ragioni militari.
Potrebbe l’Impero, in una tale crisi militare, riuscire a strappare
un trionfo politico? Una svendita dell’Iraq, che assieme alla Siria
era il solo paese a resistere alla dominazione americana, sarebbe stata una
vittoria. Non c’era alcun dubbio su questo risultato.
Il gruppo
iracheno che ha beneficiato di più dall’occupazione è
la leadership dei curdi. I curdi hanno ricevuto fondi in grande quantità
per i dodici anni precedenti alla guerra, le agenzie di intelligence hanno
sfruttato la regione come base per penetrare nel resto della nazione. Oggi
i curdi dominano le marionette dell’esercito e della polizia, hanno
definito il carattere ultrafederale della costituzione, e non è un
segreto che gradirebbero una pulizia etnica nella zona del Kirkuk che escluda
gli arabi e tutti gli altri non curdi, compresi quelli nati nella città.
Una minorità oppressa in un’epoca può rapidamente diventare
un oppressore in un’altra, come Israele continua a dimostrare al mondo.
I leader curdi, dopo avere ottenuto il Kirkuk, sono felici di essere diventati
un protettorato occidentale.
Se l’unità
dei gruppi sciiti dovesse collassare, e potrebbe farlo qualora negasse la
lussuria delle truppe americane e il supporto aereo, un nuovo patto potrebbe
essere possibile per prevenire la balcanizzazione dell’Iraq. Lo stesso
potrebbe avvenire se Teheran decidesse che un Iraq indipendente è negli
interessi della regione, ma il calcolo razionale non è mai stata prerogativa
dei mullah. Un finale felice sembra comunque lontano.
E il petrolio?
Il modello preparato al momento costerà all’Iraq miliardi in
termini di guadagni persi, mentre le multinazionali globali raccoglieranno
il bottino. I contratti preparati provvederebbero loro guadagni del 42% o
del 62%, in un settore dove i guadagni minimi della regione sono del 12%.
Mentre il petrolio resterà proprietà dello Stato in termini
legali, gli accordi di condivisione della produzione faranno concessioni ad
agenzie private. Anche questo consisterà in una vittoria sia di gruppi
come Halliburton sia di quella dei suoi padroni politici. Fino a quando il
governo iracheno appoggerà i PSA (gli accordi di condivisione della
produzione petrolifera, NdT), le truppe britanniche e americane potranno ritirare
le loro truppe e dichiarare vittoria. Il trionfo della libertà si rifletterà
nell’accordo per il petrolio. Del resto, poco altro conta.
Ma questo
accordo può durare indefinitamente senza la presenza delle truppe imperiali?
Probabilmente no. Il petrolio nel passato ha fatto risorgere movimenti nazionalisti
e ha trasformato la politica dell’Iran e dell’Iraq. I tempi sono
cambiati oggi, ma i problemi di base restano, e la guerra per il petrolio
potrebbe non finire così presto.
Articolo
originale http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1687114,00.html
Torna a inizio pagina
| |
| |
Missione italiana sotto inchiesta
Un ponte per... - Osservatorio Iraq 18 gennaio 2006
Si dovrà
votare entro breve il nuovo rifinanziamento della missione italiana in Iraq,
la cui proroga è scaduta il 31 dicembre. Sarà più difficile
però per il governo italiano presentare la necessità di finanziare
una “missione di pace” che ha tra i suoi compiti la tutela del
patrimonio iracheno e la requisizione di armi da guerra. Il 4 gennaio 2006
la procura militare ha aperto una inchiesta su quattro ufficiali della Brigata
“Pozzuolo del Friuli” per peculato, introduzione e detenzione
clandestina di armi da guerra. Nel corso di perquisizioni in abitazioni private
sono stati rinvenuti reperti archeologici.
Tutto materiale
proveniente dall’Iraq. La Brigata “Pozzuolo del Friuli”
ha infatti partecipato alla missione “Antica Babilonia” dal maggio
al settembre 2004, e il materiale che è stato rinvenuto nella caserma
Berghinz di Udine oltre cento tra kalashnikov, pistole semiautomatiche, mitragliatrici,
lanciarazzi Rpg e fucili da cecchino è stato prelevato dal teatro iracheno.
Sarà difficile, secondo Giovanni Bernardi dichiarare questa come “l’iniziativa
di un singolo”: “Il singolo che ha l’iniziativa di portare
nel proprio bagaglio o con sé materiale di armamento, non ci riesce,
perché prima di rientrare da un teatro operativo, passa, così
come facciamo noi all’aeroporto, da un metal detector. Il metal detector
controlla sia i bagagli sia l’individuo e quindi non è possibile
che il singolo abbia questa iniziativa: senz’altro è una iniziativa
di reparto”.
Una brutta
storia per la missione italiana, alla quale si aggiunge, sul piano strettamente
militare, Paul Bremer, il governatore americano che ha guidato il governo
dopo la presa di Baghdad esprime giudizio negativo sull’operato dei
militari a Nassirya. Nel suo libro ”Il mio anno In Iraq” , appena
pubblicato, così viene liquidata la missione italiana: “Il nostro
ufficio di Nassiriya è stato quasi sopraffatto perché la Forza
di Intervento Rapido dell'Italia ha impiegato sette ore per fare un percorso
di poche miglia. Siamo stati costretti ad abbassare la bandiera ieri".
Il libro di Bremer non mette sotto accusa solo gli italiani, ma più
in genere i membri della coalizione, a dispetto di quanto riportato dai media
dei singoli paesi sul comportamento dei loro eserciti. Ma la guerra raccontata
dai giornali e dalle televisioni e la guerra realmente vissuta, da una o dall’altra
parte, raramente collimano.
Sue Smith,
madre di un soldato britannico ucciso in Iraq, sintetizza così la situazione
parlando delle centinaia di soldati feriti: “ Il governo pensa che l’ignoranza
sia felicità estrema. Se si tiene la gente all’oscuro, non farà
domande. Che possibilità ha il pubblico britannico di prendere una
decisione quando tutto viene nascosto? Perché lo stanno nascondendo?
Se io so tutto su 12 [persone] che hanno perso le gambe e le braccia, perché
il pubblico non lo sa?”. Come nei media occidentali, anche nei media
iracheni si paga il prezzo del silenzio governativo, o peggio ancora quello
della sua sola voce: Charles Levinson, del Christian Science Monitor, racconta
che il maggior gruppo editoriale iracheno, IMN, proprietario della rete televisiva
Al Iraqiya, è ormai sotto il controllo del Primo Ministro sciita, Ibrahim
al Ja’afari. “Il suo ufficio … ha lavorato per trasformare
i vari media dell’IMN in portavoce delle sue politiche e degli alleati
del partito al Da’wa, assumendo e licenziando redattori, e dirigendo
la politica editoriale”.
Nel frattempo
sono diventate di pubblico dominio le notizie dell’influenza statunitense
sui media iracheni, che non si è limitata solo ai quotidiani, ma ha
coinvolto anche stazioni televisive e persino alcuni leader religiosi . Dignitari,
sceicchi ed ulema della provincia di Nineveh, nel denunciare la pesante situazione
della loro provincia, sottoposta ai continui raid delle forze sia statunitensi
sia irachene, sottolineano come:“il governo iracheno è complice
in tutti questi crimini, nell'assenza dei media, e in particolare per l'uccisione
e il rapimento di giornalisti da parte di mercenari dell'occupazione, dopo
aver terrorizzato ed escluso stazioni satellitari e arabe ed i media internazionali,
impedendo di riferire su quel che sta accadendo, per consentire il massacro
del popolo iracheno senza testimoni”.
Non mancano
solo le infrastrutture in Iraq, mancano le libertà fondamentali e quella
della libera espressione è una di queste: si viene condannati a trenta
anni di prigione per aver diffamato il leader curdo Massud Barzani, si viene
prelevati dalla propria casa distruggendo tutto per uno “sbaglio di
persona” . Si viene guardati con sospetto perché si è
“testimoni”. Era un testimone anche Alan, l’interprete e
fixer iracheno della giornalista Jill Carrol. Il 7 gennaio è stato
ucciso nel quartiere di al Adil, e la sua collega americana rapita.
Prima di lavorare come interprete, aveva un negozio di dischi, che era anche
un luogo di ritrovo per i ragazzi e le ragazze di Baghdad. Basta leggere il
tenerissimo ricordo che ne dà Riverbend nel suo blog per capire quanto
la guerra e l’occupazione abbiano, a lui e agli altri, rubato il futuro.
Fonte www.osservatorioiraq.it
Torna a inizio pagina
|
|
| |