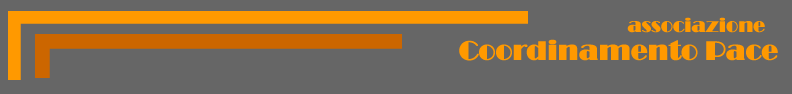|
|||||||||||||||||
|
Archivio>> Palestina>>Documenti | ||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
Basta con la guerra civile Ieri sono scesi in strada a centinaia. Donne, anziani, giovani simpatizzanti del Jihad islami e del Fronte popolare, ma soprattutto persone comuni. Con l'unico intento di chiedere ai miliziani di Hamas e Fatah di smetterla con il bagno di sangue in cui sta affogando Gaza. C'era anche il generale egiziano Burhan Hammad che sta invano tentando di mediare tra le parti. Qualcuno ha portato alla manifestazione la sua bandiera verde islamica, molti altri quella con i colori della Palestina. In corteo hanno attraversato il centro di Gaza city e si sono diretti verso le zone più pericolose, incuranti dei cecchini piazzati sui tetti degli edifici più alti pronti a fare fuoco. «Basta con la guerra civile», «Siamo fratelli», ricordavano gli striscioni che stringevano tra le mani tremanti per la paura.Ma quelle parole di buon senso, dirette al cuore di chi spara, sono state portate via dal vento caldo di una Gaza dove la vita umana ora conta ben poco, dove coloro che fino a qualche tempo fa sorseggiavano il té e fumavano il narghilé assieme ora si sparano addosso.Quando il corteo ha raggiunto una via nella quale si scontravano i miliziani, una delle due parti ha aperto il fuoco contro i manifestanti uccidendone due e ferendone altri 16. Le telecamere di al-Jazeera hanno anche ripreso giovani e donne disarmati che a calci e pugni tentavano in ogni modo di separare gli armati cacciandoli dalla strada, nonostante alcuni dei combattenti avessero a più riprese aperto il fuoco contro di loro mirando in aria o ai piedi. I due morti della manifestazione pacifista hanno inevitabilmente richiamato alla mente la guerra civile in Bosnia. Una strage conclusasi solo nel 1995. I palestinesi rischiano di replicarla. Ieri a Gaza a cadere sotto il fuoco delle opposte fazioni sono stati anche due funzionari palestinesi delle Nazioni unite che ora intendono rallentare le operazioni di assistenza umanitaria. Nessun problema invece per i 4 dei 5 cooperanti di ong italiane rimasti bloccati per alcuni giorni a Gaza city. Grazie alla Croce rossa hanno potuto lasciare Gaza dove contano di ritornare non appena la situazione sul terreno lo consentirà, per continuare l'impegno in sostegno dei civili palestinesi. Indietro hanno però dovuto lasciare la loro collega ed amica Meri Calvelli (Associazione Yalla) alla quale non è consentito entrare in territorio israeliano e quindi non ha potuto raggiungere Gerusalemme. Sono stati 22 i morti di ieri, oltre cento i feriti, e Hamas, che ormai controlla tutta Gaza - Fatah limita il proprio controllo ad alcune postazioni isolate -, minaccia un'offensiva generale se entro domani alle 19 (le 18 in Italia) le ultime forze fedeli al presidente Abu Mazen non avranno consegnato le armi. E fa sul serio, come dimostra l'attacco contro il quartier generale della Sicurezza preventiva di Khan Yunis: militanti islamici hanno scavato una galleria sotto l'edificio facendovi esplodere un potente ordigno. Ieri sera si scavava ancora tra le macerie in cerca di superstiti. Se in passato i miliziani di Fatah si erano macchiati di crimini orrendi, ora sono quelli di Hamas ad apparire impegnati in una gigantesca resa dei conti che in molti casi assume le caratteristiche di una vendetta mafiosa che non fa onore ad un movimento che fino a qualche tempo sosteneva che non avrebbe mai puntato le armi contro altri palestinesi. La caccia all'uomo è spietata e talvolta prende di mira semplici poliziotti e attivisti di Fatah che hanno soltanto eseguito ordini dei «capi» che Hamas afferma di voler colpire. I dirigenti di Fatah sono irreperibili, a cominciare dall'ex «uomo forte» Mohammed Dahlan che se ne sta al sicuro in Egitto. I vari comandanti (fra cui Rashid Abu Shbak) sono scomparsi da giorni, forse avevano capito che la resa dei conti era vicina e hanno abbandonato i loro uomini. Contro Fatah, Hamas ricorre anche alla guerra psicologica. Il suo portavoce, Sami Abu Zuhri, ha fatto appello via radio ai genitori degli agenti affinché «vadano a riprendersi i figli, e salvino loro la vita». Membri delle Brigate al-Qassam hanno telefonato ai cellulari dei loro rivali politici e li hanno esortati a consegnarsi. Secondo una radio di Hamas, le defezioni sono state centinaia. A Rafah decine di agenti delle forze di Abu Mazen hanno preferito consegnarsi alle forze egiziane, per sottrarsi ai combattimenti. Decine di miliziani di Hamas per inseguirli hanno cercato di aprire una breccia con dell'esplosivo nel muro in una zona del corridoio «Philadelphi», il tratto di 14 chilometri di frontiera tra il Sinai egiziano e la Striscia di Gaza. Le forze di sicurezza egiziane hanno dovuto circondare l'area per impedire scontri a fuoco.Il senso di impotenza e di frustrazione nei vertici di al-Fatah è forte. In Cisgiordania i primi a reagire sono stati i miliziani delle Brigate dei martiri di al-Aqsa, che hanno attaccato a Nablus decine di sostenitori di Hamas. In parte sono stati feriti, in parte sequestrati. L'offensiva di Hamas sta facendo materializzare un territorio palestinese «bicefalo»: la Cisgiordania in mano a Fatah, Gaza dominata dal movimento islamico. Una prospettiva che Israele non intende neppure prendere in considerazione e il rischio di un massiccio attacco militare contro la Striscia è molto concreto.
|
|||||||||||||||||
L'UE ha diviso i palestinesi ora tratti con Hamas L'Unione europea, come primo donatore dell'Autorità nazionale palestinese, da anni svolge un ruolo importante nelle vicende politiche di Ramallah. Dell'atteggiamento apparentemente schizofrenico dell'Europa abbiamo discusso al telefono con Luisa Morgantini, vicepresidente dell'europarlamento L'Ue non ha riconosciuto né il governo Hamas risultato dalle elezioni del gennaio 2006, né l'esecutivo di unità nazionale varato un anno dopo, ma ora ha fretta di stringere rapporti col governo Fayyad.Voglio premettere che non bisogna assolvere Hamas: sparare su altri palestinesi è una cosa assolutamente imperdonabile. Detto questo, l'Europa ha sbagliato tutto. Prima ha spinto perché nel 2006 si svolgessero le elezioni e Hamas vi prendesse parte. Poi non ha riconosciuto l'esito di un voto democratico. Ancora, ha insistito affinché nascesse un governo d'unità nazionale, ma alla fine non ha accettato nemmeno quest'ultimo, che demandava il negoziato con Israele all'Olp e, in cui Hamas, assieme ai confini del 1967, riconosceva implicitamente lo Stato ebraico. Appiattendosi sulle posizioni statunitensi, l'Ue ha dunque, di fatto, operato per la divisione del popolo palestinese
|
|||||||||||||||||
Il muro dell'apartheid Gaza nelle mani di Hamas, con militanti mascherati seduti sulla poltrona del presidente; la West Bank sull’orlo del collasso; accampamenti dell’esercito israeliano allestiti frettolosamente sulle alture del Golan; un satellite spia sopra Iran e Siria; la guerra con Hezbollah a un tiro di schioppo; una classe politica rovinata dagli scandali che fronteggia la totale perdita di fiducia da parte dell’opinione pubblica.A prima vista, sembra che le cose non vadano bene per Israele. Ma ecco l’enigma: come mai, in mezzo al caos e alla carneficina, l’economia israeliana cresce come se fosse il 1999, con un mercato azionario ruggente e tassi di crescita vicini a quelli della Cina? Thomas Friedman ha recentemente esposto sul New York Times la propria teoria. Israele “coltiva e ricompensa l’immaginazione individuale” e perciò la sua gente produce in continuazione ingegnosi progetti ad alta tecnologia, a prescindere dai disastri provocati dai suoi uomini politici. Dopo aver analizzato i progetti degli studenti di scienze ingegneristiche e informatiche della Ben Gurion University, Friedman si produce in una delle sue azzardate enunciazioni: Israele “ha scoperto il petrolio”. Questo petrolio, ovviamente, si troverebbe nelle menti dei “giovani innovatori e imprenditori israeliani”, che sarebbero troppo impegnati a fare grandi affari con Google per lasciarsi trattenere dalla politica.Ecco invece un’altra teoria: l’economia israeliana non sta crescendo a dispetto del caos che riempie i titoli dei giornali, ma proprio grazie ad esso. Questa fase di sviluppo risale alla metà degli anni ’90, quando Israele era all’avanguardia nella rivoluzione informatica, essendo tra le economie mondiali quella più dipendente dal settore tecnologico. Dopo l’esplosione, nel 2000, della bolla delle dot.com, l’economia israeliana si ritrovò devastata, affrontando il proprio anno peggiore dal 1953. Poi arrivò l’11 settembre e d’improvviso nuove prospettive di profitto si dischiusero per qualsiasi compagnia che affermasse di essere in grado di identificare terroristi in mezzo alla folla, rafforzare i confini contro gli attacchi ed estorcere confessioni da prigionieri con le labbra serrate.Nell’arco di tre anni, gran parte dell’economia tecnologica israeliana era stata radicalmente riconvertita. Per dirla in termini friedmaneschi: Israele era passato dalla produzione di strumenti di connessione per il “flat world” alla vendita di reticolati per un pianeta ridotto all’apartheid. Molti degli imprenditori di successo israeliani utilizzano la condizione del proprio paese di stato-fortezza, circondato da furiosi nemici, come una sorta di esposizione permanente, un esempio vivente di come si possa godere di relativa sicurezza anche nel mezzo di una guerra costante. Il motivo della supercrescita di Israele è che le sue compagnie stanno ora laboriosamente esportando questo modello nel resto del mondo. Le discussioni sul commercio di armamenti militari in Israele si focalizzano di solito sul flusso di armi che arriva nel paese. Gli Stati Uniti fabbricano i Caterpillar usati per abbattere le case nella West Bank e le compagnie britanniche forniscono le parti per gli F-16. Si sorvola sul business delle esportazioni di Israele, che è enorme e in continua espansione. Israele fornisce adesso 1,2 miliardi di dollari in prodotti per la “difesa” agli Stati Uniti, un incremento gigantesco rispetto ai 270 milioni di dollari del 1999. Nel 2006 Israele ha esportato 3,4 miliardi di dollari in prodotti per la difesa, oltre un miliardo in più di quanto abbia ricevuto in sovvenzioni statunitensi. Ciò fa di Israele il quarto maggior esportatore di armi del mondo, superiore perfino all’Inghilterra.Gran parte della sua crescita è dovuta al cosiddetto settore della “sicurezza interna”. Prima dell’11 settembre la sicurezza interna, come industria, esisteva a malapena. Entro la fine di quest’anno le esportazioni israeliane in questo settore raggiungeranno gli 1,2 miliardi di dollari, con un incremento del 20%. I prodotti e servizi più importanti sono le barriere ad alta tecnologia, i droni teleguidati, i sistemi d’identificazione biometrica, gli strumenti di sorveglianza audio e video, i sistemi di schedatura dei passeggeri dei voli aerei e d’interrogazione dei prigionieri. Precisamente gli strumenti e le tecnologie che Israele ha utilizzato per isolare i territori occupati.Ecco perché il caos a Gaza e nel resto della regione non rappresenta una minaccia per gli introiti di Tel Aviv e potrebbe anzi incrementarli. Israele ha imparato a trasformare una guerra infinita in una fonte di reddito, presentando lo sradicamento, l’occupazione e la segregazione del popolo palestinese come un anticipo di mezzo secolo della “guerra globale al terrorismo”. Non è un caso che i progetti dell’Università Ben Gurion, che tanto impressionano Friedman, abbiano titoli come “Nuova Matrice di Covarianza per il Rilevamento di Bersagli in Immagini Iperspettrali” e “Algoritmi per il Rilevamento e l’Aggiramento di Ostacoli”. Trenta nuove compagnie che producono articoli per la sicurezza interna sono state aperte in Israele solo negli ultimi sei mesi, grazie in buona parte a generosi sussidi governativi che hanno trasformato l’esercito israeliano e le università del Paese in incubatrici di progetti per nuove armi e sistemi di sicurezza (una cosa da tenere a mente nei dibattiti sul boicottaggio accademico). La settimana prossima le più solide fra queste compagnie verranno in Europa per l’Esposizione Aeronautica di Parigi, che per l’industria degli armamenti è l’equivalente della Settimana della Moda. Una delle compagnie israeliane che partecipano all’esposizione è la SDS (Suspect Detection Systems) che presenterà il suo Cogito1002, una specie di chiosco bianco, dall’aspetto fantascientifico, che chiede ai passeggeri dei voli aerei di rispondere a una serie di domande generate da un sistema computerizzato, tarate sul paese di provenienza, facendo loro tenere la mano su un sensore di “biofeedback”. L’apparecchio rileva le reazioni del corpo alle domande e un certo tipo di reazioni servono a etichettare il passeggero come “sospetto”. Come accade per centinaia di altre aziende di sicurezza israeliane, la SDS si vanta di essere stata fondata da veterani della polizia segreta d’Israele e di aver testato sul campo i propri prodotti sui palestinesi. Non solo la compagnia avrebbe sperimentato i terminali di biofeedback ai checkpoint della West Bank; essa afferma anche che “il progetto è sostenuto e arricchito dalla conoscenza acquisita e assimilata dallo studio di migliaia di casi di attentati suicidi in Israele”. Un’altra star dell’Esposizione Aeronautica di Parigi sarà il colosso della difesa militare Elbit, che ha in programma di presentare i suoi velivoli senza pilota Hermes 450 e 900. Stando a ciò che riferisce la stampa, in maggio Israele avrebbe utilizzato questi droni in missioni di bombardamento su Gaza. Una volta testati sui territori, essi vengono esportati all’estero: l’Hermes è già stato utilizzato al confine tra Arizona e Messico; alcuni terminali Cogito1002 sono all’esame di un ignoto aeroporto statunitense; e la Elbit, una delle compagnie che hanno contribuito a progettare la “barriera di sicurezza” intorno a Israele, si è associata alla Boeing per costruire, su richiesta della Homeland Security americana, una barriera di confine “virtuale” intorno agli Stati Uniti per la cifra di 2,5 miliardi di dollari. Da quando Israele ha iniziato a segregare i territori occupati con muri e posti di blocco, gli attivisti per i diritti umani hanno spesso paragonato Gaza e la West Bank a delle prigioni a cielo aperto. Ma nel corso della mia ricerca sull’esplosione dell’industria per la sicurezza interna in Israele (argomento che affronterò in maggior dettaglio nel mio prossimo libro The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism [La Dottrina dello Shock: l’Ascesa del Capitalismo del Disastro, NdT]), mi ha colpito il fatto che essi siano anche qualcos’altro: laboratori nei quali i terrificanti strumenti dei nostri stati di polizia vengono testati sul campo. I palestinesi, che vivano nella West Bank o in ciò che i politici israeliani chiamano già “Hamasistan”, non sono più semplici bersagli. Sono cavie. Perciò, in un certo senso, Friedman ha ragione: Israele ha trovato il petrolio. Ma il petrolio non è l’immaginazione dei suoi imprenditori tecnologici. Il petrolio è la guerra al terrorismo, la condizione di paura costante che crea una domanda senza fine di apparecchi per sorvegliare, spiare, contenere e identificare i “sospetti”. La paura, a quanto sembra, è l’ultima arrivata fra le risorse rinnovabili.
|
|||||||||||||||||
Il futuro della palestina dopo la vittoria di Hamas a Gaza Dopo la sanguinosa battaglia che ha consegnato la Striscia di Gaza nelle mani di Hamas, a Gaza City regna una calma irreale. La bandiera verde del movimento integralista palestinese sventola su tutti gli edifici più importanti della città e la quiete è interrotta solo da alcuni episodi di violenza residuale. Tra questi, il saccheggio della villa del defunto leader di Fatah, Yasser Arafat, e di Mohammed Dahlan, il suo braccio destro nella Striscia di Gaza. Di Dahlan in particolare, il nemico numero uno delle forze di Hamas a Gaza, non si sono sapute più notizie per alcuni giorni: qualcuno affermava si trovasse già all'estero per alcune cure, ed invece è notizia fresca che pare si trovi tra i circa 500 combattenti di Fatah che sono scappati dalla Striscia di Gaza, per rifugiarsi a Ramallah, ovvero nel cuore di quella Cisgiordania ancora nelle mani dell'Autorità Nazionale Palestinese. Il presidente Abu Mazen ha ricevuto il sostegno pressoché unanime della comunità internazionale ed ha ricambiato respingendo qualsiasi offerta di dialogo da parte di Hamas, che, dopo la conquista di Gaza, ha dichiarato la sua disponibilità a voler trovare una soluzione pacifica alla crisi. Anzi, in Cisgiordania Hamas è stata dichiarata organizzazione illegale ed Abu Mazen ha provveduto a sciogliere il governo di unità nazionale, presieduto dall'esponente di Hamas, Ismael Haniyeh, per nominare come nuovo primo ministro, l'ex ministro delle Finanze Salam Fayyad, personalità molto stimata in Occidente. Nei circoli della diplomazia internazionale si fa strada l'ipotesi di levare l'embargo nei confronti della Cisgiordania, come ulteriore segnale di supporto nei confronti di Abu Mazen nella sua lotta contro Hamas. Si tratterebbe senza dubbio di un segnale molto importante che, tra le altre cose, potrebbe servire per alleviare, almeno in parte, la sofferenza del popolo palestinese. Sta di fatto, comunque, che al momento non si intravede alcuna soluzione in vista se non il mantenimento almeno per un po’ dello status quo attuale, ovvero la divisione de facto del territorio dell'ex ANP tra la zona sotto controllo di Fatah (Cisgiordania) e quella sotto controllo di Hamas (Gaza).Stando a quel che affermano fonti militari israeliane, da parte delle forze armate dello Stato di Israele non vi sarebbe per ora alcun piano di ulteriore intervento militare a Gaza, cosa che è stata anche negata in maniera abbastanza chiara da parte di Meir Sheetrit, ministro per gli Alloggi e le Costruzioni dello stato ebraico. "Non c’è alcuna intenzione di rientrare in quella palude, Gaza, in questa situazione", queste le sue parole. Alle Nazioni Unite si mormora della possibilità dell'invio di una forza multinazionale di pace nella Striscia di Gaza, ma nessuno sembra particolarmente convinto dell'opportunità di tale scelta. "E' un'idea che dobbiamo esplorare ma bisogna studiare più in dettaglio quali sono i Paesi interessati", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, mentre il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha affermato che la Russia è favorevole a tale decisione solo se verrà presa con l'accordo di tutte le parti in causa. Hamas, dal canto suo, ha invece fatto conoscere la sua contrarietà a tale ipotesi ed ha affermato anzi che qualsiasi forza multinazionale sarà considerata come una forza occupante a tutti gli effetti. Inoltre per diversi Paesi, che sono già impegnati militarmente in Iraq ed Afghanistan, risulterebbe alquanto difficile inviare truppe in una zona così calda come la Striscia di Gaza, senza rischiare che esse vengano sottoposte ad un vero e proprio tiro al bersaglio da parte dei guerriglieri palestinesi. Il risultato è quindi che, almeno per ora, di tale proposta non si farà nulla. Il tutto in attesa di vedere quale potrebbe essere la reazione israeliana ad un eventuale attacco missilistico proveniente dal territorio della Striscia di Gaza, cosa considerata, purtroppo, molto probabile da tutti gli analisti.La crisi in atto è comunque il risultato di molti anni di politiche disastrose, sia dal da parte israeliana che da parte palestinese. E' cosa ormai abbastanza nota che Israele abbia finanziato, o quantomeno aiutato indirettamente, Hamas fino dall'inizio degli anni Novanta, in funzione anti Fatah ed anti Arafat. Cosa confermata nel dicembre 2001 dall'ex ambasciatore americano in Israele, Daniel Kurtzer, durante un seminario sulla religione e la politica che si è tenutosi a Gerusalemme, sponsorizzato dall'organizzazione anglo americana a favore della pace, Oz V'Shalom-Netivot Shalom. Anche fonti israeliane hanno più volte ammesso la responsabilità di Israele nella crescita del movimento islamico Hamas, non ultimo nel caso della liberazione dello sceicco Yassin nel 1996, durante il governo Netanyahu, che ha contribuito non poco al definitivo consolidamento e poi all'affermazione di Hamas nella Striscia di Gaza. Nel corso degli anni, dall'accordo di Oslo del 1993 (mai riconosciuto valido da Hamas) ad oggi, la destra israeliana e il movimento integralista palestinese hanno infatti sempre giocato "di sponda", con l'obiettivo comune di far saltare i negoziati di pace, tra attacchi kamikaze da parte palestinese e relative repressioni violente da parte israeliana nei Territori Occupati. Quando poi, dopo il fallimento dei negoziati di Camp David, i negoziati di pace si sono arenati definitivamente e Sharon è potuto salire al governo, a seguito della famigerata "camminata sulla Spianata delle Moschee" che ha dato inizio alla seconda intifada ed alla fine del governo di Arafat, Hamas ha avuto l’occasione che attendeva da tempo per dimostrare che aveva ragione a dubitare degli accordi di Oslo, ed iniziare così la sua più forte e insistente campagna di reclutamento da quando era nata.Mentre Israele giustificava il suo intervento militare contro il governo di Arafat con la necessità di far salire al potere una nuova dirigenza palestinese più malleabile e propensa alla pace, a 4 anni di distanza dall'inizio della seconda intifada, nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese distrutti dai bombardamenti israeliani e senza la presenza di un vero governo, visto che Yasser Arafat era tenuto de facto prigioniero nella sua sede di Ramallah circondata dagli israeliani, si sono tenute le elezioni municipali, che hanno visto l'ascesa di Hamas anche come movimento politico, in particolare nel territorio della Striscia di Gaza. L'anno successivo, dopo la morte di Arafat e l'ascesa al potere del meno carismatico Abu Mazen, alle elezioni politiche Hamas ha ottenuto la maggioranza dei voti popolari ed ha quindi avuto la possibilità di governare il Paese con la nomina a primo ministro di Ismael Haniyeh, il leader politico di Hamas. La reazione della comunità internazionale e di Israele a questa vittoria democratica di Hamas alle elezioni, è stata pesantissima: embargo totale nei confronti dei territori palestinesi - già in preda ad una crisi economica pesantissima - e ripetute dichiarazioni di rifiuto al dialogo con Hamas per la ripresa del processo di pace.Il resto è storia dei giorni nostri. Con il passare del tempo tra Hamas e Fatah la situazione è divenuta sempre più delicata e da questo sono derivati i primi scontri settari tra le due fazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Dopo diversi tentativi, infruttuosi, di raggiungere un accordo di coalizione tra Hamas e Fatah per un governo di unità nazionale che permettesse, quantomeno, l’allentamento dell’embargo internazionale e dopo le minacce del presidente Abu Mazen di sciogliere il governo di Hamas, nel febbraio di quest’anno, alla Mecca, si era finalmente trovato un accordo tra le due fazioni palestinesi. Questo prevedeva, tra le altre cose, il rispetto di Hamas degli accordi finora raggiunti con lo Stato di Israele, compreso dunque, anche se non esplicitamente affermato, l'accordo di Oslo del 1993. Inoltre, era stata delegata l'OLP, organizzazione nella quale Fatah è in maggioranza, come unico rappresentante del popolo palestinese per eventuali negoziati di pace con Israele. Ma questo non era bastato per abbassare la tensione: Israele ha continuato a rifiutare qualsiasi trattativa con il nuovo governo a meno che non avesse rispettato esplicitamente le condizioni poste dal Quartetto (Stati Uniti, Onu, Russia, Ue) che prevedevano il riconoscimento di Israele e la rinuncia alla violenza come forma di lotta. Nulla di questo è avvenuto ed anzi in breve tempo sono ripresi, in maniera sempre più violenti, gli scontri tra Hamas e Fatah. La tensione è aumentata fino a raggiungere l'apice con il vero e proprio colpo di Stato dell'altro giorno con la conquista militare di Gaza da parte di Hamas e il susseguente scioglimento del governo di unità nazionale da parte di Abu Mazen, che però ora controlla solo la Cisgiordania. Molti osservatori, sia all'interno che all'esterno di Israele, considerano ciò che è avvenuto in questi ultimi giorni, come la controprova che non esista nessuno tra i leader palestinesi, con cui si possa realmente intavolare una trattativa di pace. Il tutto mentre anche Israele vive una delle sue peggiori crisi politiche con il movimento Kadima del premier Olmert, al minimo storico di popolarità dopo la sconfitta in Libano e con la prospettiva, suggerita dai sondaggi di opinione, che il prossimo premier possa tornare ad essere quel Benjamin Netanyahu, esponente dell'ala più intransigente del Likud e della destra israeliana contraria agli accordi con i palestinesi. Ciononostante, la storia avrebbe dovuto già insegnare che ogni qualvolta Israele ha rifiutato di sedersi al tavolo delle trattative, Hamas ha aumentato sempre di più il proprio potere nella società e nel governo palestinese. Per cui è vitale ora che la comunità internazionale faccia sentire ancora di più ora il proprio peso per ottenere, quantomeno, la ripresa dei negoziati di pace, se non l’ottenimento di un accordo di pace vero e proprio. Sarebbe il miglior modo per dimostrare l'appoggio internazionale nei confronti del presidente Abu Mazen ed allo stesso tempo sarebbe forse l'unica possibilità per Olmert di presentarsi alle prossime elezioni evitando una sconfitta che tutti prevedono bruciante e allo stesso tempo disastrosa per le speranze future di un qualsiasi accordo di pace. Purtroppo però la ragione non sempre ha successo in politica. La storia recente delle tantissime, troppe occasioni perdute, anche in situazioni molto più promettenti di quella attuale, lascia ben poco margine di ottimismo. Sempre che non sia già troppo tardi ormai per evitare altri, ulteriori, massacri di gente innocente in quella terra, il Medio Oriente, che da cinquanta anni a questa parte non pare conoscere altro che sangue. Quasi sempre, in maggioranza innocente.
|
|||||||||||||||||
Elementi stranieri dietro la crisi di Gaza Sono almeno sei i palestinesi uccisi a Gaza e in Cisgiordania nel primo scontro con le truppe israeliane da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia. Dopo l'incursione dell'esercito si registra anche il primo raid dell'aviazione israeliana compiuto questa mattina contro basi di Hamas e della Jihad islamica nella Striscia di Gaza per cercare di colpire i responsabili del lancio di un razzo Qassam caduto sulla città israeliana di Sderot. Da parte palestinese si era risposto all'incursione con il lancio di razzi anticarro. Intanto oggi è tornato a parlare il presidente palestinese Abu Mazen, che nella sua prima uscita pubblica dopo la presa della Striscia da parte di Hamas ha dichiarato che la crisi è stata «premeditata» e fomentata da «elementi regionali» d'intesa con Hamas. Per Abu Mazen non ci sarà nessun dialogo con Hamas. «Non parleremo - ha detto - con questi terroristi, assassini e golpisti». Abbas ha assicurato inoltre di aver cercato di prevenire il conflitto "attraverso un dialogo continuo". «Quella in atto nella Striscia - ha continuato il presidente - è una guerra fra il progetto nazionale e il piccolo reame che vogliono istituire a Gaza, fra chi usa l'assassinio per raggiungere i suoi obiettivi e chi invece usa la legge». Le parole di Mahmud Abbas fanno l'eco a quanto aveva dichiarato appena questa mattina il ministro degli Esteri egiziano Ahmed Aboul Gheit che aveva accusato l'Iran di avere incoraggiato Hamas a impossessarsi della Striscia di Gaza, minacciando così la sicurezza in Medio Oriente e del confinante Egitto in particolare. Il presidente palestinese Abu Mazen ha poi accusato il movimento estremista islamico Hamas di aver tentato di assassinarlo di recente. «Ho ricevuto informazioni provenienti da Gaza secondo cui volevano assassinarmi. Ma sono andato comunque a Gaza. In seguito ho visto un video di Hamas. Nel filmato, sei persone di Hamas parlavano di 250 chilogrammi di esplosivo. Tre di loro ripetevano: questa bomba è per Abu Mazen».Emergenza umanitaria. E' forte il rischio che nella Striscia di Gaza possa scattare una vera a propria emergenza alimentare nel giro di un mese, quando cominceranno a scarseggiare farina, riso, olio e altri viveri di base. A lanciare l'allarme è l'Onu, secondo cui, a meno che Israele non riapra il valico commerciale di Karni, le riserve cominceranno ad essere insufficienti nelle prossime 2-4 settimane.Da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia, sono stati chiusi tutti i valichi, quello di Rafah a sud, quello al centro di Karni e quello a nord, verso Israele, di Erez. Secondo il consigliere personale di Abu Mazen Erekat si rischia la «catastrofe» per i 1,5 milioni di abitanti nella Striscia che hanno bisogno di 450 tonnellate di cibo al giorno ed al momento hanno scorte per circa nove giorni.Visto lo stato dei fatti avere accesso agli alimenti di base sta diventando sempre più difficile per chi vive a Gaza, considerato inoltre che l'87 per cento degli abitanti vive al di sotto della soglia povertà, con meno di 2,40 dollari (meno di due euro) al giorno. Secondo il programma alimentare mondiale (Pam), il prezzo della farina nell'area è già salito del 40 per cento. Il Pam, che assiste 275mila abitanti, ha riserve di cibo immagazzinate a Gaza solo per sette giorni, mentre l'agenzia dell'Onu che assiste i rifugiati (850mila) ha riserve di farina per dieci giorni. Il rapporto dell'agenzia Onu denuncia ancora che le scorte di carburante utilizzate dai generatori degli ospedali e dalle ambulanze si esauriranno nel giro di una settimana, a meno che non vengano saldati i pagamenti con i fornitori israeliani. Mancano anche le medicine: gli ospedali della zonna hanno bisogno di 33 tonnellate al giorno di farmaci, ma l'Oms al momento riesce a fornirne solo 8.
|
|||||||||||||||||
LABORATORIO PER UN MONDO
FORTIFICATO (Traduzione di Gianluca Freda) Gaza nelle mani di Hamas, con militanti mascherati seduti sulla poltrona del presidente; la West Bank sull’orlo del collasso; accampamenti dell’esercito israeliano allestiti frettolosamente sulle alture del Golan; un satellite spia sopra Iran e Siria; la guerra con Hezbollah a un tiro di schioppo; una classe politica rovinata dagli scandali che fronteggia la totale perdita di fiducia da parte dell’opinione pubblica.A prima vista, sembra che le cose non vadano bene per Israele. Ma ecco l’enigma: come mai, in mezzo al caos e alla carneficina, l’economia israeliana cresce come se fosse il 1999, con un mercato azionario ruggente e tassi di crescita vicini a quelli della Cina? Thomas Friedman ha recentemente esposto sul New York Times la propria teoria. Israele “coltiva e ricompensa l’immaginazione individuale” e perciò la sua gente produce in continuazione ingegnosi progetti ad alta tecnologia, a prescindere dai disastri provocati dai suoi uomini politici. Dopo aver analizzato i progetti degli studenti di scienze ingegneristiche e informatiche della Ben Gurion University, Friedman si produce in una delle sue azzardate enunciazioni: Israele “ha scoperto il petrolio”. Questo petrolio, ovviamente, si troverebbe nelle menti dei “giovani innovatori e imprenditori israeliani”, che sarebbero troppo impegnati a fare grandi affari con Google per lasciarsi trattenere dalla politica.Ecco invece un’altra teoria: l’economia israeliana non sta crescendo a dispetto del caos che riempie i titoli dei giornali, ma proprio grazie ad esso. Questa fase di sviluppo risale alla metà degli anni ’90, quando Israele era all’avanguardia nella rivoluzione informatica, essendo tra le economie mondiali quella più dipendente dal settore tecnologico. Dopo l’esplosione, nel 2000, della bolla delle dot.com, l’economia israeliana si ritrovò devastata, affrontando il proprio anno peggiore dal 1953. Poi arrivò l’11 settembre e d’improvviso nuove prospettive di profitto si dischiusero per qualsiasi compagnia che affermasse di essere in grado di identificare terroristi in mezzo alla folla, rafforzare i confini contro gli attacchi ed estorcere confessioni da prigionieri con le labbra serrate.Nell’arco di tre anni, gran parte dell’economia tecnologica israeliana era stata radicalmente riconvertita. Per dirla in termini friedmaneschi: Israele era passato dalla produzione di strumenti di connessione per il “flat world” alla vendita di reticolati per un pianeta ridotto all’apartheid. Molti degli imprenditori di successo israeliani utilizzano la condizione del proprio paese di stato-fortezza, circondato da furiosi nemici, come una sorta di esposizione permanente, un esempio vivente di come si possa godere di relativa sicurezza anche nel mezzo di una guerra costante. Il motivo della supercrescita di Israele è che le sue compagnie stanno ora laboriosamente esportando questo modello nel resto del mondo. Le discussioni sul commercio di armamenti militari in Israele si focalizzano di solito sul flusso di armi che arriva nel paese. Gli Stati Uniti fabbricano i Caterpillar usati per abbattere le case nella West Bank e le compagnie britanniche forniscono le parti per gli F-16. Si sorvola sul business delle esportazioni di Israele, che è enorme e in continua espansione. Israele fornisce adesso 1,2 miliardi di dollari in prodotti per la “difesa” agli Stati Uniti, un incremento gigantesco rispetto ai 270 milioni di dollari del 1999. Nel 2006 Israele ha esportato 3,4 miliardi di dollari in prodotti per la difesa, oltre un miliardo in più di quanto abbia ricevuto in sovvenzioni statunitensi. Ciò fa di Israele il quarto maggior esportatore di armi del mondo, superiore perfino all’Inghilterra.Gran parte della sua crescita è dovuta al cosiddetto settore della “sicurezza interna”. Prima dell’11 settembre la sicurezza interna, come industria, esisteva a malapena. Entro la fine di quest’anno le esportazioni israeliane in questo settore raggiungeranno gli 1,2 miliardi di dollari, con un incremento del 20%. I prodotti e servizi più importanti sono le barriere ad alta tecnologia, i droni teleguidati, i sistemi d’identificazione biometrica, gli strumenti di sorveglianza audio e video, i sistemi di schedatura dei passeggeri dei voli aerei e d’interrogazione dei prigionieri. Precisamente gli strumenti e le tecnologie che Israele ha utilizzato per isolare i territori occupati.Ecco perché il caos a Gaza e nel resto della regione non rappresenta una minaccia per gli introiti di Tel Aviv e potrebbe anzi incrementarli. Israele ha imparato a trasformare una guerra infinita in una fonte di reddito, presentando lo sradicamento, l’occupazione e la segregazione del popolo palestinese come un anticipo di mezzo secolo della “guerra globale al terrorismo”. Non è un caso che i progetti dell’Università Ben Gurion, che tanto impressionano Friedman, abbiano titoli come “Nuova Matrice di Covarianza per il Rilevamento di Bersagli in Immagini Iperspettrali” e “Algoritmi per il Rilevamento e l’Aggiramento di Ostacoli”. Trenta nuove compagnie che producono articoli per la sicurezza interna sono state aperte in Israele solo negli ultimi sei mesi, grazie in buona parte a generosi sussidi governativi che hanno trasformato l’esercito israeliano e le università del Paese in incubatrici di progetti per nuove armi e sistemi di sicurezza (una cosa da tenere a mente nei dibattiti sul boicottaggio accademico). La settimana prossima le più solide fra queste compagnie verranno in Europa per l’Esposizione Aeronautica di Parigi, che per l’industria degli armamenti è l’equivalente della Settimana della Moda. Una delle compagnie israeliane che partecipano all’esposizione è la SDS (Suspect Detection Systems) che presenterà il suo Cogito1002, una specie di chiosco bianco, dall’aspetto fantascientifico, che chiede ai passeggeri dei voli aerei di rispondere a una serie di domande generate da un sistema computerizzato, tarate sul paese di provenienza, facendo loro tenere la mano su un sensore di “biofeedback”. L’apparecchio rileva le reazioni del corpo alle domande e un certo tipo di reazioni servono a etichettare il passeggero come “sospetto”. Come accade per centinaia di altre aziende di sicurezza israeliane, la SDS si vanta di essere stata fondata da veterani della polizia segreta d’Israele e di aver testato sul campo i propri prodotti sui palestinesi. Non solo la compagnia avrebbe sperimentato i terminali di biofeedback ai checkpoint della West Bank; essa afferma anche che “il progetto è sostenuto e arricchito dalla conoscenza acquisita e assimilata dallo studio di migliaia di casi di attentati suicidi in Israele”. Un’altra star dell’Esposizione Aeronautica di Parigi sarà il colosso della difesa militare Elbit, che ha in programma di presentare i suoi velivoli senza pilota Hermes 450 e 900. Stando a ciò che riferisce la stampa, in maggio Israele avrebbe utilizzato questi droni in missioni di bombardamento su Gaza. Una volta testati sui territori, essi vengono esportati all’estero: l’Hermes è già stato utilizzato al confine tra Arizona e Messico; alcuni terminali Cogito1002 sono all’esame di un ignoto aeroporto statunitense; e la Elbit, una delle compagnie che hanno contribuito a progettare la “barriera di sicurezza” intorno a Israele, si è associata alla Boeing per costruire, su richiesta della Homeland Security americana, una barriera di confine “virtuale” intorno agli Stati Uniti per la cifra di 2,5 miliardi di dollari. Da quando Israele ha iniziato a segregare i territori occupati con muri e posti di blocco, gli attivisti per i diritti umani hanno spesso paragonato Gaza e la West Bank a delle prigioni a cielo aperto. Ma nel corso della mia ricerca sull’esplosione dell’industria per la sicurezza interna in Israele (argomento che affronterò in maggior dettaglio nel mio prossimo libro The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism [La Dottrina dello Shock: l’Ascesa del Capitalismo del Disastro, NdT]), mi ha colpito il fatto che essi siano anche qualcos’altro: laboratori nei quali i terrificanti strumenti dei nostri stati di polizia vengono testati sul campo. I palestinesi, che vivano nella West Bank o in ciò che i politici israeliani chiamano già “Hamasistan”, non sono più semplici bersagli. Sono cavie. Perciò, in un certo senso, Friedman ha ragione: Israele ha trovato il petrolio. Ma il petrolio non è l’immaginazione dei suoi imprenditori tecnologici. Il petrolio è la guerra al terrorismo, la condizione di paura costante che crea una domanda senza fine di apparecchi per sorvegliare, spiare, contenere e identificare i “sospetti”. La paura, a quanto sembra, è l’ultima arrivata fra le risorse rinnovabili.
|
|||||||||||||||||
Cosa vuole Hamas? Gaza City – Gli avvenimenti degli ultimi giorni a Gaza sono stati descritti in Occidente come un colpo di Stato. Di fatto, sono stati il contrario. Diciotto mesi fa, il nostro partito Hamas ha vinto le elezioni parlamentari palestinesi ed è entrato in carica con il primo ministro Ismail Haniye, ma non ha mai ricevuto il passaggio reale dei poteri da parte di Fatah, il partito sconfitto. Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, adesso ha tentato di rimpiazzare il governo vincente di Hamas con uno proprio, riportando Fatah al potere mentre molti dei nostri membri eletti del Parlamento languiscono nelle prigioni israeliane. Questo è il vero colpo di Stato. Dal giorno in cui ha vinto le elezioni generali nel 2006, Hamas ha offerto a Fatah l’opportunità di unire le forze e formare un governo di unità. Ha tentato di coinvolgere la comunità internazionale per spiegare il suo piano di pace. Coerentemente ha offerto un cessate-il-fuoco di 10 anni con gli israeliani per tentare di creare un atmosfera di quiete nella quale comporre i nostri contrasti. Hamas ha anche aderito a un cessate-il-fuoco unilaterale di 18 mesi allo scopo di normalizzare la situazione sul terreno. Nessuno di questi punti sembra essere stato riconosciuto nella copertura mediatica degli ultimi giorni.Né è sembrato evidente a molte persone in occidente che le agitazioni a Gaza e in Cisgiordania sono state accelerate dalla politica americana e israeliana consistente nell’armare elementi dell’opposizione di Fatah che vogliono attaccare Hamas e costringerci ad abbandonare l’incarico. Per 18 mesi abbiamo tentato di trovare il modo per coesistere con Fatah, entrando a far parte di un governo di unità, concedendo anche ruoli chiave nell’esecutivo a loro e alle richieste internazionali, negoziando fino all’ultimo momento per tentare di assicurare la sicurezza a tutto il nostro popolo nelle strade di Gaza.Tristemente, è divenuto evidente che non tutti I funzionari di Fatah stavano negoziando in buona fede. La scorsa settimana ci sono stati attentati alla vita di Haniya, e alla fine siamo stati costretti a tentare di prendere il controllo di una situazione molto pericolosa allo scopo di assicurare la stabilità politica e ristabilire la legge e l’ordine.Le strade di Gaza adesso sono calme per la prima volta dopo molto tempo. Abbiamo iniziato a disarmare alcuni narco-trafficanti e le bande armate, e speriamo di restituire un senso di sicurezza e stabilità ai cittadini di Gaza. Vogliamo riportare I bambini a scuola, rimettere nuovamente in funzione i servizi di base, e assicurare miglioramenti economici a lungo termine per il nostro popolo.Il nostro intento dichiarato quando abbiamo vinto le elezioni era di realizzare le riforme, mettere fine alla corruzione e portare la prosperità economica al nostro popolo. Il nostro unico obiettivo è costituito dai diritti dei palestinesi e dal buon governo. Adesso ci auguriamo di creare un clima di pace e tranquillità all’interno della nostra comunità che spianerà la strada per la fine del conflitto interno e determinerà il rilascio del giornalista britannico Alan Johnston, il cui rapimento a marzo da parte di membri che non facevano parte di Hamas rappresenta una macchia sulla reputazione del popolo palestinese.Respingiamo i tentativi di dividere la Palestina in due parti e di far passare Hamas per una forza estremista e pericolosa. Continuiamo a credere che esiste ancora una possibilità di stabilire una tregua di lungo termine. Ma
ciò non accadrà senza il pieno coinvolgimento della comunità
internazionale con Hamas.Ogni ulteriore tentativo di metterci ai margini,
costringere per fame il nostro popolo alla sottomissione o attaccarci militarmente
proverà che gli Stati Uniti e i governi israeliani non sono sinceramente
interessati ad assistere alla fine delle violenze. Osservatori imparziali
nelle prossime settimane saranno in grado di farsi un’opinione autonoma
sulle reali intenzioni di ogni parte.*Ahmed Yousef è il consigliere
politico di Ismail Haniye, che lo scorso anno è divenuto Primo Ministro
palestinese. (Traduzione di Carlo M. Miele)
|
|||||||||||||||||
Tra Hamas e Fatha: quale destino per la Palestina? Due Stati per un solo
popolo, Il terremoto innescato qualche giorno fa dalla conquista armata della
Striscia di Gaza da parte dei miliziani di Hamas sembra, in effetti, aver
diviso a metà i destini dei palestinesi. Da una parte il fondamentalismo
dell'"Hamastan", come è stato subito chiamato il mini-Stato
palestinese autoproclamatosi nella Striscia, dove aleggia l'incombente imposizione
del diritto islamico della Sharia e da cui i fedeli di Abu Mazen continuano
a fuggire; dall'altro la terra di Fatah, in Cisgiordania, dove il presidente
dell'Anp si è affrettato a dichiarare disciolto il governo di unità nazionale - in carica da appena tre mesi e composto da esponenti di entrambe
gli schieramenti - e ha nominato un esecutivo di emergenza guidato dal moderato
Salam Fayyad. Al centro, reciproche accuse di golpe e, soprattutto, tanta
violenza tra gli stessi membri di un popolo che sembra aver dimenticato la
causa comune per cui combatte da oltre mezzo secolo.
|
|||||||||||||||||
Israele non vuole la pace l momento della verita'
e' arrivato e va detto: Israele non vuole la pace. Fino a poco tempo fa era ancora possibile accettare il ritornello del "non abbiamo un interlocutore" per la pace e del " non e' ancora tempo" di negoziare con i nemici. Oggi, la nuova realta' di fronte ai nostri occhi non lascia spazio a dubbi e lo stancante ritornello "Israele e' per la pace" e' caduto in frantumi. E' difficile determinare quando c'e' stata la rottura. E' stato l'assoluto rigetto dell'iniziativa saudita? Il rifiuto di riconoscere quella siriana? Le interviste di Pasqua del primo ministro Olmert? La ripulsione alle dichiarazioni rilasciate a Damasco da Nancy Pelosi, la portavoce della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che presumevano che Israele fosse pronto a rinnovare il dialogo di pace con la Siria? In Israele intere generazioni sono state svezzate nell'illusione enell'incertezza della possibilita' di realizzare la pace con i nostri vicini. Nei nostri giorni piu' verdi, David Ben-Gurion ci diceva che avrebbe portato la pace, se solo gli fosse data la possibilita' di incontrare i capi arabi. Israele ha chiesto negoziazioni dirette per una questione di principio e gli israeliani ne hanno tratto grande orgoglio per il fatto che il loro quotidiano impegno per la pace celava le piu' alte ambizioni dello Stato. Ci era stato detto che non c'erano interlocutori per la pace e che la piu' grande ambizione degli arabi era di distruggerci. Abbiamo bruciato i ritratti del "tiranno egizio" nei nostri falo' del trentatreesimo giorno dell'Omer ed eravamo convinti che tutte le colpe per la mancanza di pace erano dei nostri nemici. Dopo arrivo' l'occupazione, seguita dal terrorismo, Yasser Arafat, il secondo summit di Camp David fallito e l'ascesa di Hamas al potere, ed eravamo sicuri, sempre sicuri, che era tutta colpa loro. Neppure nei nostri sogni piu' feroci avremmo potuto credere che sarebbe venuto il giorno in cui l'intero mondo arabo ci avesse teso la mano in segno di pace e che Israele avrebbe voltato le spalle al gesto. Sarebbe stato ancora piu' pazzesco immaginare che Israele si tirasse indietro adducendo come scusa quella di non volere fare arrabbiare l'opinione pubblica domestica. Il mondo e' stato capovolto
ed ora e' Israele che sta in prima linea nel rifiuto. Quella che era la politica
di rifiuto di pochi, una avanguardia degli estremisti, e' ora diventata la
politica ufficiale di Gerusalemme. Il terrorismo, usato da
Israele come l'ultima scusa per il suo rifiuto, serve solo ad Olmert per fargli
recitare, ad nauseum, "Se i palestinesi non cambiano, non combattono
il terrorismo e non ottemperano a nessuno dei loro obblighi, allora non usciranno
mai dal loro perenne caos".
Non e' solo Olmert che fa resistenza. Una figura di primo piano del Labour party ha detto la scorsa settimana che " ci vorranno da cinque a dieci anni per riprendersi dal trauma ". Ora la pace e' niente di piu' che una minacciosa ferita, e nessuno che ne parli ancora in termini di benefici sociali di massa che essa apporterebbe allo sviluppo, alla sicurezza e alla liberta' di movimento nella regione e nell'istituire una societa' piu' giusta. Come una piccola Svizzera, oggi ci stiamo concentrando piu' sul tasso di cambio del dollaro e sulle dichiarazioni di malversazione sollevate contro il Ministro delle Finanze che sulle fatidiche opportunita' che svaniscono ai nostri occhi prima di riconoscerle tali. Mai abbiamo mai avuto un'opportunita' come questa. Anche se non e' sicuro che le iniziative siano davvero solide e credibili, o che siano basate sull'inganno, nessuno ha fatto un passo avanti per sfidarle ne' tanto meno riconoscerle. Quando Olmert sara' un nonno anziano, che cosa dira' ai suoi nipoti? Che ha fatto di tutto in nome della pace? Cosa diranno i suoi nipoti? (Traduzione di Nicola Flamigni)
|
|||||||||||||||||
Le colpe palestinesi e quelle USA e UE Intervista a Leila Shahid, rappresentante dell'Olp in Europa, ci parla della
tragedia che sta insanguinando Gaza e cancellando le speranze di uno stato
della Palestina D: A Gaza continuano
gli scontri. D: E quali sono le responsabilità da parte palestinese? Riguardano sia Hamas che
Fatah. Hamas, sorpreso dall'ampiezza del successo elettorale, non era pronto
ad assumere il potere. Doveva sapere che, persistendo nel rifiuto di riconoscere
Israele e continuando a propugnare la lotta armata, per l'Unione europea -
principale finanziatore di servizi sociali e assistenza economica -, non sarebbe
stato un interlocutore. Anche con Arafat l'aiuto europeo era subordinato a
un'intesa sull'esistenza di due stati. Neanche Fatah, d'altronde, aveva previsto
un voto di sfiducia di così grandi proporzioni. Persino regioni cristiane
hanno votato Hamas. Alcune componenti di Fatah, però, hanno voluto
risolvere la questione con la forza, rifiutando ogni proposta, procrastinando
la formazione di un governo di coalizione, boicottando Hamas con un atteggiamento
antidemocratico. Certo, sia nel campo di Hamas che in quello di Fatah ci sono
forze interessate a far cadere il governo di coalizione. Certo, le correnti
di Hamas ricevono armi dai loro alleati, ma le armi nelle mani di Fatah, da
chi vengono? Usa e Israele permettono l'arrivo di armi a tutte le parti. Il programma del governo di coalizione nazionale, che ha incluso Hamas, Fatah e gli indipendenti, era simile a quello di Fatah. L'Ue avrebbe potuto negoziare con la corrente più pragmatica di Hamas, invece ha spinto la popolazione alla guerra civile, avallando la strategia degli Usa nella regione: dall'Iraq alla Palestina, passando per il Libano, favorire guerre civili per giustificare la propria presenza militare in Medioriente. Ma oggi, al parlamento europeo c'è una maggiore consapevolezza del fallimento delle sanzioni. Tutti i gruppi di sinistra hanno chiesto di ristabilire le relazioni dirette col governo di coalizione. Lei è stata con
Arafat dal '69. Non crede che il vuoto lasciato dal rais sia parte di questa
crisi? D: Ma non c'è anche una crisi politica e morale di Fatah? Il fallimento elettorale di Fatah è legato a quello del processo di pace. Nel '93, Fatah ha presentato gli accordi di Oslo come la soluzione dell'occupazione militare, ha promesso uno stato palestinese per il '99, deludendo e facendo infuriare la popolazione. Poi ha rinviato troppo il processo di rinnovamento. L'ultimo congresso è dell'89: da 18 anni non c'era vita democratica nel partito, e tantomeno quindi in una gestione di governo. Più della corruzione, è stata l'assenza di democrazia a deludere i cittadini. Il loro è stato un voto di protesta, che hanno pagato caro. D: Bisogna sciogliere l'Anp? Sarebbe irresponsabile. Anche se è molto indebolita e confrontata alla crisi più grave dalla sua fondazione, l'Anp è frutto di un lungo percorso storico-politico del movimento nazionale palestinese: ci sono voluti 59 anni per costruirla. Piuttosto, occorre un'assunzione di responsabilità. Magari, si può pensare all'invio di una forza internazionale (non di interposizione), che protegga la popolazione civile.
|
|||||||||||||||||
Cercando disperatamente la sicurezza In Israele, il concetto
di «sicurezza» è un concetto potente.
|
|||||||||||||||||
Viaggio in Cisgiordania tra i mille ghetti del muro AD ABU DIS primo sobborgo arabo «murato» all’uscita di
Gerusalemme. Un inferno di cemento e filo spinato. Abu Dis, Ramallah, Tulkarem,
Qalqilya, qui vive il popolo dei senza speranza, ostaggio di Israele ma anche
delle bande armate palestinesi che dettano legge nei Territori Ma un viaggio lungo il Muro che divide la Cisgiordania dallo Stato ebraico
è innanzitutto un viaggio, angosciante, nella sofferenza dei senza
speranza. A un muro già innalzato si accompagnano tratti di un muro
in via di edificazione. E laddove non vi sono barriere di cemento e di filo
spinato, ci pensano i ceck-point istituiti dall'esercito israeliano a spezzare
in mille frammenti territoriali le città e i villaggi della Cisgiordania.
Percorrendo il tratto di strada che collega Abu Dis ai ceck-point di Ramallah,
Tulkarem, Qalqilya, assistiamo a scene che toccano il cuore: un'anziana donna
che cerca, non riuscendoci, di scavalcare il muro. Cade e si rialza più
volte, spargendo sul terreno i sacchetti con la frutta e verdura. Accanto
a lei, un bambino di non più di quattro-cinque anni piange e prova
a sorreggere l'anziana palestinese. I segni di una quotidiana violenza li
ritrovi nelle macerie delle case rase al suolo dai bulldozer israeliani, in
ciò che resta delle auto sventrate dai carri armati di Tsahal. I segni
di un presente che non lascia spazio alla speranza li leggi negli sguardi
smarriti, impauriti, dei bambini che affollano i ceck-point chiedendo l'elemosina
o vendendo acqua e tè alla menta. I segni del degrado li respiri dalle
montagne di rifiuti che affiancano la barriera israeliana. La rabbia si mischia
al dolore, l'umiliazione alla dignità della povera gente, ostaggio
di Israele ma anche delle bande armate palestinesi che dettano legge nei Territori.
Villaggi-fantasma, strade dissestate, fogne a cielo aperto. E ancora: reticolati
che circondano intere città, aree un tempo agricole spianate dai bulldozer.
E poi le scritte sui lastroni di cemento armato, che raccontano sofferenza
e dignità di un popolo. Scritte come: «resistere vuol dire esistere».
Sono queste le immagini che rimangono impresse nella mente in un viaggio al
di là del Muro. Un viaggio in una terra divisa, espropriata, «insediata». Suor Marie Dominique Croyal è la direttrice della Casa di Riposo per anziani di N.S.dei Dolori., a Gerusalemme Est. A pochi passi dall'entrata, è stata eretta la «barriera difensiva». Questa è la sua testimonianza: «Questo muro l'hanno già scavalcato migliaia di persone: studenti, mamme con i bimbi in braccio e persone anziane… Numerose sono state le cadute a volte mortali. Alcuni mesi fa abbiamo chiamato l'ambulanza per soccorrere un uomo di circa 65 anni, che era caduto dal muro a capofitto ed aveva perso conoscenza». « L'ambulanza - prosegue Sr Marie Dominique - è arrivata dopo mezz'ora e all'andata, al crocevia di Betania, è stata perquisita dall'esercito, che ha fatto scendere la moglie del ferito, ritardando le cure. Quello che succede ai piedi di questo muro è divenuto intollerabile…». Neanche la più fertile mente diplomatica può immaginare, oggi, di ricomporre questa miriade di puzzle territoriali in uno Stato. Da Qalqilya a Tulkarem, da Ramallah a Nablus: sono decine i racconti che ho ascoltato di nuclei familiari divisi dal Muro, di malati impossibilitati a raggiungere gli ospedali e i luoghi di cura all'interno della Cisgiordania. La barriera di cemento armato che «avvolge» Gerusalemme è alta 8 metri, il doppio del muro di Berlino, sovrastata ogni 300 metri da torri di controllo, potenziata da trincee profonde due metri: costeggiarla dà un senso di asfissia. Laddove attraversa aree urbane - il 10% del percorso, ma con la più alta densità di popolazione - il Muro è composto da blocchi di cemento armato alti dai 6 ai 9 metri. Nelle aree rurali, invece, il Muro assume la forma di una barriera larga dai 50 agli 80 metri e composta da vari elementi: filo spinato, trincea, rete metallica, sensori di movimento, pista di pattugliamento, e striscia di sabbia. Non soltanto il Muro non segue la «Green Line» del 1967, ma esso
ripiega su se stesso creando 22 enclavi. La crescita del Muro violenta la
memoria: a Tulkarem c'era un mercato fatto di baracche e prefabbricati: era
un punto di incontro per noi giornalisti che ci addentravamo nei Territori:
quel mercatino era famoso per i suoi deliziosi panini caldi al sesamo. Adesso
c'è il Muro: È alto otto metri e da una parte e dall'altra corre
il filo spinato e un fossato, e dove c'erano campi coltivati ora i contadini
vedono, impotenti, l'erba che cresce selvaggia e le olive che cadono nelle
reti. Qalqilya, città a nord-ovest della Cisgiordania, è il
maggior comune palestinese. Con una popolazione di più di 42mila abitanti,
essa è anche il centro di riferimento per 32 villaggi vicini, cioè
altre 90 mila fanno affidamento sulla città per i servizi sanitari
e l'istruzione. Un affidamento che si fa sempre più etereo, perché
Qalqilya è stata completamente circondata da una barriera lunga 14
km.
|
|||||||||||||||||
40 anni di occupazione israeliani in Palestina Noi vecchi siamo testimoni della storia e, in quanto tali, scomodissimi a
noi stessi.
Ma quello che unisce Bassam
e me non è solo la morte a cui l’Occupazione ci ha condannato.
Quello che ci unisce è soprattutto la fede e la volontà di crescere
i figli che ci sono rimasti in modo che essi non permettano mai più
che politici corrotti, avidi e affamati di potere e generali assetati di sangue
e conquiste, abbiano dominio sulle loro vite e li mettano gli uni contro gli
altri. Non permetteranno più che il razzismo, che si è diffuso
in questo Paese, li conduca fuori dal sentiero della pace e della fratellanza.
Perché solo quella fratellanza può abbattere il muro di razzismo
che si sta costruendo davanti ai nostri occhi. Da quarant’anni il razzismo
e la megalomania tiranneggiano le nostre vite. Quarant’anni durante
i quali più di quattro milioni di persone non conoscono il significato
di “libertà di movimento”. Quarant’anni in cui i
bambini palestinesi nascono e crescono da reclusi nelle loro case, che l’Occupazione
ha trasformato in prigioni, privandoli fin dall’inizio di tutti i diritti
a cui gli esseri umani hanno titolo in quanto esseri umani. Quarant’anni
durante i quali i bambini israeliani sono stati educati al razzismo di un
tipo che, nel mondo civile, era rimasto sconosciuto per decenni. Quarant’anni
durante i quali hanno imparato ad odiare i vicini soltanto perché sono
i vicini, a temerli senza conoscerli, a vedere un quarto dei cittadini dello
Stato come un pericolo demografico e un nemico interno, e a relazionarsi con
gli abitanti dei ghetti creati dalla politica di occupazione come con un problema
che deve essere risolto. Perché il razzismo elimina la vergogna. Questo razzismo ha eretto per se stesso un monumento a propria immagine – il monumento di un brutto muro di cemento, rigido, minaccioso e invasivo. Un monumento che proclama al mondo intero che la vergogna è stata bandita da questo Paese. Questo muro è il nostro muro della vergogna, esso è la testimonianza del fatto che noi ci siamo trasformati da luce per le nazioni “ad un oggetto di disgrazia per le nazioni e il dileggio per tutti i paesi” E questa sera dobbiamo
domandarci: cosa ne abbiamo fatto della nostra vergogna? Come allontaneremo
la disgrazia? Ma per prima e più importante cosa, come è che
la vergogna non ci impedisce di dormire la notte? Come è che permettiamo
che metà dei nostri salari vengano usati per compiere crimini contro
l’umanità? Come è che siamo riusciti a ridurre la vergogna
a due colonne sul quotidiano e a non dedicarle più dei pochi minuti
che destiniamo ad una lettura frettolosa degli articoli di Gideon Levy e Amira
Hass, come quando uno legge la cronaca di uno scenario già noto in
precedenza? Come è successo che siamo riusciti ad impacchettare l’infinita
sofferenza quotidiana, la fame, la denutrizione, i traumi dei bambini, l’invalidità,
la condizione di orfani e il lutto in una parola alienante: “politica”? Com’è che
tutte le splendide istituzioni del mondo stanno a guardare e non riescono
a fare una sola cosa per salvare un bambino dalla morte o rimuovere un blocco
di calcestruzzo dal muro della vergogna? Com’è che tutte le organizzazioni
per la pace e i diritti umani non riescono a fermare i gipponi delle Guardie
di Frontiera che arrivano a terrorizzare e uccidere gli alunni delle scuole,
e non sono in grado di fermare un bulldozer nel suo percorso per distruggere
una casa con i suoi occupanti dentro, di salvare un albero di olivo dalla
distruzione, o una bambina che si è persa mentre andava a scuola e
si è trovata sulla traiettoria dei soldati dell’Occupazione? Questa sera noi dobbiamo chiedere aiuto al mondo per liberare noi stessi dalla vergogna. Questa sera dobbiamo spiegare al mondo che se vuole salvare il popolo di Israele e il popolo palestinese dall’olocausto imminente che minaccia tutti noi è necessario che condanni la politica di occupazione, il dominio della morte deve essere fermato nel suo percorso. Tutti i criminali di guerra che svestono le uniformi e cominciano a viaggiare per il mondo devono essere arrestati, processati e messi in prigione invece di avere la possibilità di gioire dei piaceri della libertà, mentre si stanno ancora trascinando dietro un tintinnante salvadanaio pieno di crimini di guerra. E per noi è arrivato
il momento di smettere di consegnare i nostri figli ad un sistema educativo
che radica in loro valori falsi e razzisti ed insegna loro che il proprio
contributo alla società si riassume nel fare violenza ed uccidere i
figli di altre persone. E’ venuto il momento per noi di spiegare loro
che la popolazione di questo luogo non è divisa fra Ebrei e non-Ebrei
come è scritto nei loro libri scolastici, ma in esseri umani che vogliono
vivere in pace nonostante tutto, e persone che hanno perduto la loro umanità
e ricavano piacere dalla distruzione e dalla devastazione. E’ venuto
il tempo per noi di spiegare ai nostri figli dove vivono. Quindi l’unico modo per impedire che i nostri figli diventino strumenti nelle mani della macchina di distruzione è raccontare loro la storia di questo luogo, disegnare per loro i suoi confini, aiutarli a conoscere i vicini, la loro cultura, le loro usanze, la loro gentilezza e i loro diritti sulla terra dove hanno vissuto per molte generazioni prima che i Pionieri sionisti arrivassero nella Terra Promessa di Israele. E soprattutto insegnare loro a non sottomettersi alla Stato, a non rispettare la sua autorità, perché questo Stato è governato da ladri e opportunisti, che non controllano i loro impulsi, né quelli sessuali né altri, persino nei tempi più neri e reggono questo Stato secondo le leggi della Mafia: “Tu hai ucciso uno dei miei – io ucciderò un centinaio dei tuoi. Tu mi hai lanciato una bomba fatta in casa – io sgancerò un centinaio delle bombe più distruttive e sofisticate del mondo che non lasceranno neanche una traccia di te, della tua famiglia e dei tuoi vicini. Tu hai bruciato una delle mie auto così io brucerò una delle tue città.” Questa è la logica del mondo della criminalità. Questa sera dobbiamo pensare
a quelli che sono condannati a morire n ftro e a quelli che sono condannati
a cadere nel crimine sotto la copertura della legge e dell’uniforme.
Dobbiamo salvarli tutti. Dobbiamo insegnare a tutti loro a non obbedire a
degli ordini che, anche se sono legali secondo le leggi razziali di questo
Stato, sono manifestamente e chiaramente inumani.E soprattutto, questa sera
dobbiamo fermarci un attimo, tutti noi, e guardare il viso della piccola Abir
Aramin, la sua testa colpita alla nuca da un proiettile, il cui assassino
non si troverà mai di fronte ad un processo in questo Paese e non verrà mai punito nel modo in cui merita, e domandare a noi stessi,
|
|||||||||||||||||
Un'intera nazione prigioniera di Israele L'uso selettivo della lingua da parte dei media e la censura per omissione del giornalismo occidentale coprono la scientifica violenza israeliana Gaza deve (dovrebbe) essere mostrata per quello che è: un laboratorio israeliano, sostenuto dalla comunità internazionale, dove gli essere umani vengono usati come conigli per testare le pratiche più perverse di soffocamento economico e riduzione alla fame Si sta consentendo a Israele di distruggere la nozione stessa di Stato palestinese e di tenere prigioniera un'intera nazione. Questo appare in modo evidente dagli ultimi attacchi su Gaza, la cui sofferenza è diventata una metafora della tragedia imposta ai popoli in Medio Oriente ed oltre. Secondo il notiziario britannico Channel 4 News, questi attacchi «erano mirati contro importanti militanti di Hamas» e contro «l'infrastruttura di Hamas». La Bbc ha parlato di uno «scontro» tra gli stessi militanti e gli F-16 israeliani. Consideriamo uno di questi scontri. L'automobile dei militanti è stata fatta esplodere da un missile partito da un cacciabombardiere. Chi erano questi militanti? Secondo la mia esperienza, tutti gli abitanti di Gaza sono militanti in quanto resistono al loro carceriere e aguzzino. Quanto alla «infrastruttura di Hamas», si trattava della sede del partito che ha vinto le elezioni democratiche dell'anno scorso in Palestina. Dire questo darebbe una cattiva impressione. Suggerirebbe che le persone a bordo dell'automobile e tutti gli altri nel corso degli anni, i bambini e gli anziani che si sono anche loro «scontrati» con i cacciabombardieri, sono stati vittima di una mostruosa ingiustizia. Suggerirebbe la verità. «Secondo alcuni». ha detto il reporter di Channel 4, «Hamas
ha sollecitato questo ...». Forse si riferiva ai razzi sparati contro
Israele dall'interno della prigione di Gaza, che non hanno ucciso nessuno.
Secondo il diritto internazionale, una popolazione occupata ha il diritto
di usare le armi contro le forze di occupazione, ma questo diritto non viene
mai citato. Il giornalista di Channel 4 ha fatto riferimento a una «guerra
infinita». Non c'è nessuna guerra. C'è la resistenza della
popolazione più povera, più vulnerabile sulla terra a una perdurante
occupazione illegale imposta dalla quarta più grande potenza militare
al mondo, le cui armi di distruzione di massa vanno dalle bombe cluster ai
congegni termonucleari, pagate dalla superpotenza \. Soltanto negli ultimi
sei anni, ha scritto lo storico Ilan Pappé, «le forze israeliane
hanno ucciso più di 4.000 palestinesi, la metà dei quali bambini». Il 19 maggio, il Guardian ha ricevuto questa lettera da Omar Jabary al-Sarafeh, un abitante di Ramallah. «La terra, l'acqua e l'aria sono sotto costante osservazione da parte di un sofisticato sistema di sorveglianza militare... La striscia di Gaza deve \ essere mostrata per ciò che è... un laboratorio israeliano sostenuto dalla comunità internazionale dove gli esseri umani vengono usati come conigli per testare le pratiche più drammatiche e perverse di soffocamento economico e di riduzione alla fame». Il giornalista israeliano Gideon Levy ha descritto la fame che colpisce gli
abitanti di Gaza, più di un milione e 250 mila persone, e le «migliaia
di persone ferite, rese disabili e scioccate dalle bombe, che non possono
ricevere alcuna assistenza... Ombre di esseri umani vagano tra le rovine...
Sanno solo che tornerà, e sanno cosa significherà questo per
loro: più prigionia nelle loro case per settimane, più morte
e distruzione in proporzioni mostruose». Più del 40% della popolazione di Gaza è formato da bambini sotto i 15 anni. Dando conto di uno studio sul campo per il British Medical Journal effettuato per 4 anni nella Palestina occupata, il dottor Derek Summerfield ha scritto che «due terzi dei 621 bambini uccisi ai check-point, per strada, mentre andavano a scuola, nelle loro case, sono morti per piccole armi da fuoco che li hanno colpiti in più della metà dei casi alla testa, al collo e al petto: la ferita del cecchino». Un mio amico che lavora all'Onu li chiama «figli della polvere». La loro stupenda infantilità, la loro chiassosità, le loro risate, il loro incanto, tradiscono il loro incubo. Ho incontrato il dottor Khalid Dahlan, uno psichiatra che dirige uno di svariati
progetti di salute infantile sul territorio a Gaza. Dahlan mi ha parlato della
sua ultima ricerca. «La statistica che personalmente trovo insopportabile»
ha detto «è che il 99.4% dei bambini che abbiamo preso in esame
soffrono per un trauma. Se si guardano i tassi di esposizione al trauma, si
capisce il perché: il 99.2% del gruppo di studio ha avuto la casa bombardata;
il 97.5% è stato esposto ai gas lacrimogeni; il 96.6% ha assistito
a sparatorie; il 95.8% ha assistito a bombardamenti e funerali; quasi un quarto
ha visto dei componenti della propria famiglia feriti o morti». Ci sono eccezioni lodevoli. L'inviato della Bbc rapito, Alan Johnston, è una di esse. Eppure, nella valanga di notizie sul suo rapimento, non si citano mai le migliaia di palestinesi rapiti da Israele, molti dei quali non rivedranno le loro famiglie per anni. Per loro non ci sono appelli. A Gerusalemme, l'Associazione stampa estera documenta come i suoi membri siano sottoposti al fuoco e alle intimidazioni da parte dei soldati israeliani. In un periodo di 8 mesi altrettanti giornalisti, compreso il responsabile della Cnn a Gerusalemme, sono stati feriti dagli israeliani, alcuni di loro gravemente. In ciascun caso l'Associazione stampa estera ha protestato. In ciascun caso, non c'è stata una risposta soddisfacente. Una censura per omissione attraversa profondamente il giornalismo occidentale su Israele, specialmente negli Usa. Hamas è liquidata come «un gruppo terroristico votato alla distruzione di Israele», che «rifiuta di riconoscere Israele e vuole combattere, non dialogare». Questo discorso sopprime la verità: il fatto che Israele sta distruggendo la Palestina. Inoltre le proposte di Hamas, avanzate da tempo, di un «cessate il fuoco» di 10 anni vengono ignorate, insieme a un recente, promettente spostamento ideologico al suo interno, che vede una accettazione storica della sovranità di Israele. «La carta non è il Corano», ha detto uno di Hamas, Mohammed Ghazal. «Storicamente crediamo che tutta la Palestina appartenga ai palestinesi, ma ora stiamo parlando della realtà, delle soluzioni politiche». L'ultima volta che ho visto Gaza, mentre mi recavo in auto verso il check-point israeliano con il filo spinato, ho potuto assistere allo spettacolo di bandiere palestinesi che sventolavano dall'interno dei compound recintati. Erano stati i bambini, mi spiegavano. Fabbricano le aste con delle bacchette legate insieme, e uno o due di loro si arrampicano in cima a un muro tenendo la bandiera in silenzio. Lo fanno quando ci sono degli stranieri in giro, e pensano che potranno dirlo al mondo. (Traduzione Marina Impallomeni)
|
|||||||||||||||||
LA NOTTE DELLA PALESTINA Forse una speranza, ho pensato ieri quando la gente di Gaza è scesa in piazza contro la guerra fratricida. Poi Al Jazeera ha mostrato il corteo bersagliato da entrambi i contendenti, e sono cadute le prime vittime. Si può ripartire solo da questo coraggio, da chi non si è fatto intimidire da armi, calci e sputi. Ora c'è solo rabbia, vergogna, stupore. I due contendenti in armi non rappresentano più il disagio e le aspirazioni palestinesi. È lotta per il potere, in assenza di potere, sulle macerie della Palestina ancora sotto l'occupazione israeliana che dura da sessant'anni. Tornano in mente le parole di Frantz Fanon nella Rivoluzione tradita: «In mancanza di un progetto politico e culturale alternativo si riproduce la dimensione del nemico occupante». Così azzerano anni di lotta drammatica, ma anche di riscatto politico, umano e culturale. Le parti che si fronteggiano, nel metodo e nel contenuto, sembrano estranei a questa storia. Ma perché questa trasformazione dopo la vittoria elettorale di Hamas. Perché hanno sconvolto un popolo che aveva fatto, comunque, la sua scelta? La risposta sta nel meccanismo democratico inceppato che non ha permesso a chi ha vinto le elezioni di esercitare il suo diritto-dovere di governare. I responsabili sono troppi: innanzitutto la stessa Al Fatah e il presidente Abu Mazen che, insieme ad Israele e alla Comunità internazionale, ha frapposto mille ostacoli tra Hamas e la possibilità di governare. Il resto lo hanno fatto l'isolamento politico, l'embargo economico, le uccisioni mirate, le incursioni militari quotidiane, gli arresti dei membri del governo e del Parlamento, il Muro, i nuovi insediamenti. Israele e gli Stati uniti - il rapporto dell'inviato dell'Onu Alvaro de Soto parla di effetto «devastante» per «l'appoggio incondizionato dato dalla Casa bianca ad Israele» - hanno imposto un assedio finanziario, minacciando le banche internazionali, impedendo l'arrivo di fondi raccolti nel mondo per la popolazione alla fame. È così cresciuto un caos non calmo, con una deriva malavitosa. E l'ultimo accordo della Mecca tra Hamas e Fatah che aveva posto fine agli scontri precedenti dando vita al governo di unità nazionale accolto con gioia nei Territori, non ha modificato né l'intransigenza d'Israele, né le condizioni materiali dei palestinesi. L'embargo e l'isolamento internazionale continuano. Altri ministri e parlamentari sono stati rapiti e rinchiusi nelle carceri israeliane. L'accordo della Mecca prevedeva l'allontanamento di tutti i falchi responsabili degli scontri. Hamas ha allontanato i propri - quelli che oggi guidano la protesta e la cui ferocia in queste ore è scellerata - ma Abu Mazen ha confermato e promosso l'eminenza grigia Dahlan. E le forze dell'ordine hanno continuato a rifiutare gli ordini del ministro degli interni, costringendolo alle dimissioni. Infine le dichiarazioni di Israele e di Bush, sulle intenzioni di sostenere con armi e denaro le forze dell'ordine alle dipendenze di Abu Mazen in funzione anti-Hamas, hanno aperto la voragine dei sospetti. Oggi «allegramente» Israele sostiene che è la divisione dei palestinesi ad impedire la ripresa delle trattative. In verità Israele, che non trattava neanche quando l'interlocutore c'era, non tratta perché è contro una soluzione politica che ponga fine alla sua occupazione sulla Palestina.I palestinesi si uccidono e suicidano il sogno della terra più amata. Ma il mondo occidentale, Europa compresa, che sta a guardare è il vero responsabile. La sua guerra e le sue false promesse hanno riaperto per sempre la ferita del Medio Oriente.
|
|||||||||||||||||
ISRAELE
e gli OMICIDI MIRATI Mentre noi entriamo nel 41° anno dell’occupazione militare israeliana, una delle politiche più sinistre inflitteci è rappresentata dai cosiddetti “omicidi mirati”. Israele non applica la pena di morte eccetto che per i palestinesi che vivono sotto il governo militare israeliano della West Bank e nella Striscia di Gaza. Là, sospetti oppositori dell’occupazione israeliana sono uccisi di routine senza imputazione, giudice o giuria. Innocenti a cui capita di trovarsi nelle vicinanze di un “obiettivo” di Israele spesso sono vittime di esecuzioni sommarie. In aprile, la diciassettenne Bushra Breghish stava camminando nella sua camera da letto, mentre studiava per gli esami. Un cecchino israeliano, di uno squadrone inviato per arrestare suo fratello, le ha sparato in fronte, uccidendola all’istante. Tutto ciò che teneva in mano era un libro. L’altra settimana nella piazza centrale di Ramallah, in pieno giorno, forze israeliane sotto copertura hanno sparato alle gambe a un ragazzo di 22 anni, Omar Abu Daher. Dopo che è caduto, e poteva essere tranquillamente arrestato, un assassino israeliano gli ha sparato nella nuca a distanza ravvicinata, poi ha dato un calcio al suo corpo, per confermarne la morte. La morte di questi giovani palestinese non è rara, né casuale. Sono le vittime di una politica riconosciuta apertamente. Per decenni, Israele ha assassinato leader palestinesi all’estero, seguendo i macabri calcoli dei suoi scienziali politici e esperti di intelligence per i quali persino un ridotto numero di assassinii può ritardare se non distruggere il nostro movimento nazionale. Israele ha affermato di colpire coloro che sono colpevoli di aver compiuto o pianificato atti di violenza. In realtà, i leader politici palestinesi, poeti, giornalisti e altri professionisti e artisti sono stati uccisi. Israele ha iniziato gli “omicidi mirati” nella Striscia di Gaza negli anni ’70, e ha ampliato questa pratica durante la prima Intifada, svoltasi fra il 1987 e il 1993. La gioventù palestinese ha affrontato i blindati israeliani con poco più che slogan e pietre. Israele ha condannato (a morte, ndr) i loro “obiettivi” sulla base di un mero sospetto. Da allora hanno firmato la condanna a morte di centinaia e più, compresi passanti come la giovane Bushra che studiava per la maturità. Dal settembre 2000 più di 400 palestinesi sono stati assassinati in esecuzioni extragiudiziarie. Circa la metà erano innocenti passanti e, almeno 44, bambini. Queste esecuzioni extragiudiziarie sono crimini di guerra. Il governo di unità palestinese ha offerto di porre fine a tutte le forme di violenza se Israele avesse fatto altrettanto e avesse terminato l’uso della violenza contro i palestinesi, sia nella West Bank che nella Striscia di Gaza. (…) Non abbiamo speranza di successo in questo obiettivo se Israele non ci verrà incontro a metà strada. I palestinesi giustamente rifiuterebbero un governo che protegga le vite israeliane mentre non riesce a proteggere quelle palestinesi, che sono state sacrificate 30 volte in più rispetto a quelle israeliane negli ultimi 17 mesi. Israele ha risposto con l’escalation degli attacchi contro Gaza e con gli omicidi extragiudiziari nella West Bank. Il suo obiettivo politico è qualcos’altro se non la pace? Gli assassini israeliani dei sette anni trascorsi hanno ripetutamente frantumato le tregue unilaterali con i Palestinesi e impossibilitato qualsiasi prospetto di trattative. Perché Israele ha riacceso costantemente la violenza? È possibile che la nostra compiacenza a negoziare le nostre differenze sia più pericolosa della minaccia militare che la nostra popolazione assillata potrebbe radunare mai contro i sei più potenti eserciti del mondo? Potrebbe essere che l'Israele cerchi di terminare il sistematico spodestamento dei Palestinesi cominciato nel 1948, quando 750mila palestinesi sono stati guidati o sono fuggiti nel timore dalle loro case e dalla patria? La violenza inflitta ai palestinesi permette a Israele di schivare le trattative di pace e fornisce la copertura per continuare la confisca di terra palestinese e la costruzione di colonie ebree nelle terre che ha sottratto nel 1967?Dopotutto, la “sicurezza” era la giustificazione iniziale per gli insiediamenti di Israele e “necessità militare” era il pretesto per il sequestro delle nostre terre. La “sicurezza” razionalizza il sistema segregato stradale che Israele ha costruito nella West Bank, sistemando i coloni israeliani ebrei dovunque desiderassero andare, mentre i palestinesi devono negoziare per ottenere dei luoghi decrepiti. La “sicurezza” è servita dai 500 e oltre blocchi stradali e checkpoints israeliani che punteggiano il nostro territorio, che limitano e soffocano la nostra economia, e dal Muro di separazione che Israele ha costruito, rinchiudendo le nostre comunità in piccoli Banthustan che funzionano come le prigioni a cielo aperto. “Sicurezza” è perché Israele dice che non cederà mai la Valle del Giordano, che occupa quasi il 30% della West Bank. Infatti, la sicurezza sia per gli israeliani sia per i Palestinesi è reciprocamente interdipendente, non reciprocamente esclusiva. Israele non può avere la sicurezza mentre la rifiuta ai Palestinesi. Quando Israele sarà disposto a rinunciare alla violenza, scoprirà che ad aspettarlo ci sarà un partner per la pace.
|
|||||||||||||||||
La lunga notte di Gaza Frustrazione, vergogna e rabbia. Ecco cosa provo per ciò che sta accadendo
a Gaza. La mente confusa corre subito ad Abdul che un giorno mi disse: “Sono
nato nella Terra Santa, ma avrei voluto una casa meno disumana. Il mio nemico
è stato scelto dal Signore come eletto, ma non mi lascia pregare in
pace. Il mondo mi ama e vuole liberarmi, ma ogni giorno aggiunge un nuovo
anello alla catena della mia prigione. Sono nato in un giorno di coprifuoco.
Mio figlio è stato partorito durante la guerra. Desideravo sapere che
profumo ha la libertà e mi sono trovato per dieci anni in galera. Aspiravo
a fare l’insegnate di storia e faccio il falegname. Niente mobili, porte
o persiane, costruisco solo croci di legno di ulivo. E’ pregiato, sai,
e ha un sapore così lontano, così famigliare… vorresti
vederne una?”. Siamo ad un passo dal baratro e l’unica consolazione è che non è la prima volta. Abbiamo resistito fin troppo: quattro guerre, due deportazioni, cinquant’anni di occupazione militare, confisca di case e di terreni, campi profughi permanenti dimenticati dall’Onu e dagli uomini giusti, due processi di pace gestiti male, ingerenza araba e occidentale, politici nostrani incapaci, civili armati fino ai denti per contrastare l’esercito israeliano che aveva esteso le sue frontiere fino ai nostri cortili, finanziamenti personali camuffati da aiuti internazionali, ritiro unilaterale da una striscia senza speranza, elezioni libere e democratiche mai convalidate dalla Comunità Internazionale ed infine quell’arma quanto mai pacifica e nello stesso tempo lenta e micidiale per la gente comune che è l’embargo. Occorrono varie generazioni prima che funzioni e nel frattempo il rischio che tutto cambi è molto alto: il regime nemico, per strani intrecci internazionali, può addirittura divenire un amico. Hamas non è un gruppo di terroristi, ma è un partito popolare islamico voluto e nato da Israele per contrastare Arafat agli inizi degli anni ottanta, quando l’Olp faceva il bello e il cattivo tempo. Il movimento era impegnato nei territori in tutti i settori: assistenza agli anziani, ai malati e ai parenti dei detenuti nelle carceri israeliane, creazione di campi di lavoro, di scuole e di università. Insegnava perfino alla povera gente nei campi profughi l’igiene per evitare malattie e ridurre la mortalità infantile. La maggior parte dei suoi dirigenti sono laureati e gran lavoratori e, a differenza di quelli di al-Fatah, nessuno vive di rendita. In mancanza di aiuti internazionali hanno imparato in fretta ad autofinanziarsi e chiunque ha la possibilità di accedere a micro-crediti. Con tutto ciò molti di noi palestinesi non si riconoscono nella loro idea di resistenza così anacronistica, ma hanno vinto le prime libere elezioni e nessuno ama perdere da vincente. E finché la cosiddetta ala moderata della società palestinese non si assumerà tutte le sue responsabilità e smetterà di giocare solamente sul fatto di essere vista di buon occhio dall’Occidente per governare, Hamas continuerà a vincere ad oltranza ogni appuntamento elettorale. Tutto ciò Abu Mazen l’ha capito molto bene, come anche Israele ed i suoi alleati. Tutti hanno voluto giocare con il fattore tempo: “Quanto tempo potranno resistere in una vita fatta di embargo e di prigione? Hamas consentirà il trascorrere di tutto questo tempo morto?” .Molti ora si domandano cosa stia succedendo a Gaza. Come si può rispondere ad una domanda così violenta quando nessuno ha mai fatto nulla per evitare questa guerra incivile? Certo, anche noi palestinesi abbiamo le nostre colpe. Non abbiamo mai capito in tempo che non contiamo niente, che noi non c’entriamo nulla con la tragedia degli Ebrei: quando sono arrivati qui erano già orfani. Avremo dovuto pagare il conto altrui? Tanto ne siamo stati costretti! Paradossalmente al di fuori della Palestina entrambi siamo poco desiderati, in Occidente come in Oriente. Forse bastava questo a farci ragionare e sedere attorno ad un tavolo e decidere il danno minore per il nostro destino da disperati. Ma abbiamo preferito dare ragione alla nostra follia collettiva. Karim, a proposito di pazzia, un giorno mi disse: “Per chiudere l’interruttore di questo delirio e vivere in pace potremmo distruggere il Muro del Pianto, la moschea di al-Aqsa e la Basilica dalla Natività!” Così, però, non avremo più la luce.
|
|||||||||||||||||
Hanno iniziato loro "Abbiamo lasciato Gaza e loro ci sparano i Qassam" - non esiste una formulazione piu' precisa del punto di vista che sta prevalendo [ndt, in Israele]. "Hanno iniziato loro", sara' la risposta ripetitiva a chiunque cerchi di argomentare, ad esempio, che poche ore prima del primo Qassam caduto nella scuola di Askelon, che non ha causato danni, Israele ha seminato distruzione nella Universita' islamica di Gaza. Israele sta causando black out energetici, mantiene l'assedio, bombarda e spara, assassina e imprigiona, uccide e ferisce civili, inclusi bambini e neonati in misura orrenda, ma "Hanno iniziato loro". C'e' stata anche una "rottura delle regole" condotta da Israele: ci e' permesso bombardare qualunque cosa vogliamo ma a loro non e' concesso lanciare Qassam. Quando sparano un Qassam su Askelon, si tratta di "una escalation del conflitto", e "quando noi bombardiamo una universita' e una scuola, e' assolutamente giusto. Perche'? Perche' hanno iniziato loro". Ecco perche' la maggioranza pensa che tutto il giusto stia dalla nostra parte. Come in un bisticcio nel cortile di scuola, l'argomento su chi ha iniziato e' l'argomento moralmente vincente di Israele per giustificare qualunque ingiustizia. Allora, chi realmente ha iniziato? E poi, abbiamo "lasciato Gaza?" Israele ha lasciato Gaza solo parzialmente, e in modo non chiaro. Il piano di disimpegno, che era stato etichettato con titoli divertenti come "ripartizione" e "fine dell'occupazione", ha significato lo smantellamento delle colonie e la partenza da Gaza delle Forze di Difesa, ma non ha cambiato in niente le condizioni di vita della popolazione della Striscia. Gaza e' ancora una prigione e i suoi abitanti sono ancora condannati a vivere in poverta' e oppressione. Israele rinchiude esternamente il mare, l'aria e la terra, eccetto che per una limitata valvola di salvezza al crossing di Rafah. Non possono visitare i loro parenti della Cisgiordania o cercare lavoro in Israele da cui l'economia di Gaza ha dipeso per circa 40 anni. Alcuni beni possono essere trasportati, altri no. Gaza non ha alcuna possibilita' di scappare alla poverta' in queste condizioni. Nessuno fara' investimenti, nessuno puo' svilupparsi, nessuno si puo' sentire libero la' dentro. Israele ha lasciato la gabbia, ha buttato via la chiave e ha lasciato i residenti al loro amaro destino. Adesso, nemmeno dopo un anno, il disengagement sta ritornando indietro, con molta piu' violenza. Che cosa potremmo ancora aspettarci? Che Israele possa ritirarsi unilateralmente, ignorando brutalmente e immoralmente i loro bisogni e che loro sopporteranno in silenzio il loro amaro destino e non continueranno a lottare per la loro liberta', per le loro vite o per la loro dignita'? Abbiamo promesso un passaggio di sicurezza con la Cisgiordania e non abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo promesso di liberare i prigionieri e non abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo sostenuto elezioni democratiche per poi dopo boicottare la leadership legalmente eletta, confiscando fondi che gli appartengono, e dichiarandogli guerra. Avremo potuto ritirarci da Gaza con dei negoziati e in modo coordinato, rafforzando intanto la leadership palestinese, ma ci siamo rifiutati di farlo. E ora, ci pentiamo di questa "mancanza di leadership?" Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per minare la loro societa' e leadership, assicurandoci quanto piu' possibile che il disengagement non sarebbe stato un nuovo capitolo nelle nostre relazioni con la nazione vicina, e ora siamo stupiti dalla violenza e dall'odio che abbiamo coltivato con le nostre mani. Cosa sarebbe potuto accadere se i palestinesi non avessero lanciato i Qassam? Israele avrebbe tolto il blocco economico da Gaza? Avrebbe aperto il confine ai lavoratori palestinesi? Incoraggiato gli investimenti a Gaza? Nonsense. Se i Gaziani fossero rimasti seduti, come Israele si aspetta da loro, il loro caso sarebbe scomparso dall'agenda - qui e nel resto del mondo. Israele potrebbe continuare con la convergenza che ha significato soltanto servire i propri obiettivi, ignorando i loro bisogni. Nessuno si sarebbe dato pensiero per il destino della gente di Gaza se loro non avessero reagito violentemente. Questa e' l'unica amara verita', ma con calma sono trascorsi i primi venti anni dell'occupazione e noi non abbiamo mosso un dito per porvi fine. Al contrario, coperti dalla calma, abbiamo costruito un'enorme e criminale impresa coloniale. Con le nostre stesse mani, noi stiamo ancora una volta spingendo i palestinesi ad usare le insignificanti armi che possiedono; e in tutta risposta impieghiamo un intero immenso arsenale a nostra disposizione, e continuiamo a lamentarci che "Hanno iniziato loro". Abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con l'occupazione e siamo legati al dovere di porvi fine, una fine reale e completa. Abbiamo iniziato con la violenza. Non c'e' violenza peggiore che quella di chi occupa, usando la forza su un intera nazione, cosi' che la domanda su chi per primo ha sparato e' ad ogni modo un evadere, fornendo un quadro distorto. C'erano, anche dopo Oslo, quelli che dichiaravano "abbiamo lasciato i territori", in una simile commistione di cecita' e bugie. Gaza e' in serio pericolo, condannata a morte, all'orrore e alle difficolta' quotidiane, lontana dagli occhi e dal cuore degli israeliani. Stiamo mostrando solo i Qassam. Vediamo solo i Qassam. La Cisgiordania e' ancora sotto lo stivale dell'occupazione, le colonie stanno crescendo, e qualunque mano tesa per un negoziato, inclusa quella di Ismail Haniyeh, viene immediatamente respinta. E dopo tutto questo, se ancora qualcuno pensa in modo diverso, la risposta vincente e' presto detta: "Hanno iniziato loro". Hanno iniziato e il giusto e' dalla nostra parte, mentre la realta' e' che non hanno iniziato loro e che noi non siamo dalla parte del giusto
|
|||||||||||||||||
Morire di cancro a Gaza. Storia di Fatma Barghouth che voleva vivere di Luisa Morgantini - Parlamentare Europea - di ritorno da Gaza, 7 Gennaio 2006 Fatma Barghouth è morta il 24 Dicembre a 29 anni, divorata da un cancro che dal seno si è esteso alla colonna vertebrale. E’ stata sepolta nel cimitero di Gaza città. Nella tomba non è sola, i corpi di altre due donne sono seppelliti
con lei. Troppa gente muore a Gaza e non ci sono più spazi. La famiglia
avrebbe voluto darle sepoltura nel cimitero nei pressi del campo profughi
di Jabalia dove, per i morti, vi è ancora un po’ di terra disponibile. Vi dirò delle sue vicissitudini per raggiungere l’ospedale israeliano
dove l’attendevano per essere curata , vi dirò della dedizione
dei Medici per i Diritti Umani, un associazione israeliana che si batte contro
le persecuzioni e le discriminazioni quotidiane nel campo della salute subite
dai palestinesi da parte delle autorità israeliane (Physicians for
Human Rights, PHR www.phr.org.il), si prendono cura dei malati palestinesi
che senza il loro aiuto morirebbero o non potrebbero mai raggiungere un ospedale
specializzato israeliano. Troppe volte, quando doveva recarsi a fare la chemioterapia, il check point
di Erez, il confine che divide Gaza Nord da Israele, era interdetto.Fatma,
mentre il dolore la divorava, passava ore ed ore, sola, in attesa di poter
vedere il cancello di ferro aprirsi per poter entrare in Israele. Fatma non poteva nemmeno vederli, loro invece, seduti e nascosti nelle loro
gabbie, la osservavano dalle telecamere. Lei sentiva solo gli ordini da voci
che arrivavano dall’alto da altoparlanti gracchianti, ordini dati in
ebraico,di cui, lei, ma ogni palestinese o straniero che passa, capiva solo
il si e il no. Fatma, scopre di avere un nodulo al seno Quando per la prima volta , il 15
aprile 2003, si era recata all’ ospedale di Gaza, il Shifa Hospital,
per verificare il nodulo che aveva scoperto al seno, il medico l’ aveva
sottoposta ad un x-ray e ad una biopsia. Il primo esame era risultato, dopo
dieci giorni di attesa, insoddisfacente. Altra biopsia e dopo due settimane
di attesa il medico le disse di non preoccuparsi, il nodulo era benigno, si
trattava, le disse, di un “fibroadenoma”. A giugno il tumore si
era ingrossato e Fatma aveva sentito di avere altri due piccoli grumi. Dopo
varie insistenze, il medico accettò di asportarle il nodulo, due settimane
dopo il reparto di Oncologia le diede i risultati dicendo che il tumore asportato
era benigno. Il 13 Novembre, Fatma chiese l’ intervento dei PHR. Il professore Rafi
Waldan riuscì a darle un appuntamento urgente per il 25 Novembre. Ogni volta che doveva recarsi all’ospedale dovevano intervenire i medici
israeliani, e malgrado ciò, ogni volta doveva attendere ore e ore prima
di poter attraversare il cancello del checkpoint. Nessuno dei suoi familiari
poteva accompagnarla, nessun permesso per loro era stato accordato. Il 9 febbraio Fatma deve recarsi all’ospedale per togliere il tumore. Arriva a Erez molto presto al mattino, attende, sola, fino alle 17.30. Intervengono i medici israeliani, l’avvocato, chiamano tutti persino la giornalista Carmela Menashe di “Kol Israel”, ma la soldatessa che aveva il permesso di entrata per Fatma non era sul posto, era addetta ai servizi di cucina e nessuno poteva sostituirla. Finalmente alle 18.30, Fatma può passare. Arriva all’ospedale e il giornosuccessivo la operano. Due giorni dopo il medico la informa che il tumore si è sparso ed è necessaria una vasectomia totale. Sempre sola, malgrado i medici avessero richiesto più volte di concedere il permesso per alcuni famigliari. Sola, in un ospedale i cui medici erano solidali con lei, ma non parlavano la sua lingua. Sola con tutta la sua angoscia, la sua rabbia e il suo dolore. Dimessa, torna a Gaza. Il 25 marzo, altro appuntamento in preparazione della
radioterapia. Il permesso non viene concesso, le è proibito lasciare
Gaza. Nuovo appuntamento,due settimane dopo, questa volta riesce a passare.
Il suo trattamento consiste in 25 giorni consecutivi di radioterapia. Pagate trentamila shekels forse arriverete a vedere Fatma, prima che muoia
. Ma neppure sorelle e padre arrivarono quel giorno. Al check point di Erez dopo avere atteso lunghe ore, la polizia di frontiera rifiutava l’entrata a meno che ciascuno di loro versasse un deposito di garanza di 30.000 shekel (quasi seimila euro). Dopo l’intervento del solito avvocato Yossi Tzur, la polizia ha mostrato una volontà di compromesso, invece di trentamila shekels si riduceva la somma a ventimila. Impossibile per la famiglia trovare quei soldi. Altra causa in Tribunale, finalmente il 9 agosto hanno il permesso ma ancora
non passano. Fatma però peggiora, fa fatica a respirare. Il medico dell’ospedale
di Tel Hashomer, le dice di tornare da lui senza ritardi. Si ricomincia una nuova pratica per il permesso. Il coordinatore palestinese
dice che gli israeliani non ricevono nessuna richiesta, la invia il 19 settembre. Quando la morte di una persona aiuta quella morente a vivere. Si riprende la trafila, il permesso è finalmente pronto il mattino
del 29 settembre. Fatma è in un ambulanza con altri pazienti. Tutti
diretti allo stesso ospedale. Sulla strada di Beit Lahiyah verso Erez, l’ambulanza
è costretta a fermarsi per operazioni militari in corso. Alle 16.30
erano ancora fermi, il tentativo di arrivare a Erez attraverso un altro percorso
è fallito, alle 17.40 l’ambulanza e il suo carico tornano a Gaza. Il 4 ottobre il permesso non c’è ancora. Fatma viene ricoverata
all’ospedale di Gaza sotto la tenda a ossigeno. Un paziente malato di
cancro era morto, erano rimasti due giorni del suo trattamento chemioterapico,
lo usano per Fatma. Una settimana dopo il DCO dice a PHR di presentare la richiesta del nuovo permesso al coordinatore sanitario palestinese, Ahmad Abu Raza, ma lui è bloccato, dal coprifuoco, nel campo profughi di Nuseirat. Il giorno successivo arriva a Gaza, ma non può presentare la richiesta di Fatma, il fax israeliano è rotto. Notizia vera , ne hanno conferma i medici del PHR che chiedono agli israeliani di coordinarsi a voce con Ahmad. Lo fanno, ma dicono che d’ora in poi non basteranno i permessi, sarà necessario anche coordinarsi. La mattina del 14 ottobre Fatma non riesce a stare in piedi , può
andare solo in ambulanza che però non riesce a passare per le strade
distrutte. I PHR riescono a trovare un veicolo della Croce Rossa, l’unico
capace di passare attraverso le rovine. Ma non è finita, verso le ore
13, prima di arrivare ad Erez nei pressi del villaggio di Abraj al-Awda, il
veicolo della Croce Rossa viene preso a fucilate dai soldati israeliani. L’agonia di Fatma è finita quel giorno, quando ha chiuso definitivamente
gli occhi: il 24 dicembre del 2004. Io controllavo con estremo sforzo la rabbia, il dolore, l' indignazione. Ho anche ringraziato l’ufficiale israeliano. Mi chiedo fino a quando permetteremo tutto questo, fino a quando la Comunità Internazionale permetterà questo scempio dei diritti, della compassione e dell’umanità. Lo so, domanda retorica.
|
|||||||||||||||||
Considerazioni sulle elezioni palestinesi Milano, febbraio 2006 di Roberto Giudici e Piero Maestri (Action for Peace - Milano) presenti in Palestina in qualità di osservatori internazionali in occasione delle elezioni del Consiglio Legislativo Palestinese svoltesi il 25 gennaio 2006 La campagna elettorale Timori Perché “osservatori”? La festa elettorale Ma il nostro giro è stato soprattutto l’occasione per vivere
insieme alle/ai palestinesi una giornata che si vedeva benissimo loro stesse/i
consideravano importante, forse addirittura “storica”. E abbiamo
avuto la sensazione fisica di quanto non fossero minimamente disturbate/i
dalla nostra presenza, che è diventata in qualche modo parte della
festa. Anche al sud della Striscia, nelle città e nei campi profughi di Khan
Younes, Al Mawasi, Rafah al confine con l’Egitto, zona “interdetta”
agli osservatori internazionali dalle stesse Nazioni Unite e dall’Unione
Europea, il famoso buco nero in preda al caos, l’atmosfera in realtà
non cambia: di festa e di grande partecipazione consapevole. Alle 19.00 precise cominciano le operazioni di scrutinio. Partecipiamo anche
in questo caso come osservatori dividendoci in diversi seggi della scuola
di Al Karmel a Gaza City. I risultati elettorali Per quanto riguarda I seggi assegnati su base locale, i risultati danno: Hamas 45 seggi; Fatah 17 seggi; Indipendenti 4 seggi. Questo porta all’assegnazione totale e definitiva dei seggi è
stata: Questo ci porta a fare alcune considerazioni, importanti per comprendere
quale sia stato effettivamente il voto dei palestinesi. In secondo luogo va riconosciuta ad Hamas una forte capacità organizzativa, prima di tutto per come si è presentata: nei distretti locali ha presentato esattamente il numero di candidati corrispondenti ai seggi disponibili, mentre Fatah si divideva tra i suoi candidati ufficiali e altri membri del partito che si presentavano come indipendenti – contribuendo così a disperdere voti, in un meccanismo di fatto maggioritario (che infatti ha totalmente cancellato le liste minori). Questo è uno dei segnali della crisi di Fatah, divisa tra notabili locali, giovani militanti, gruppi di potere legati alla loro presenza nell’Autorità ecc. Anche per questo i candidati locali di Hamas sono risultati più credibili e affidabili. Infine è chiarissimo che i risultati del voto sono caratterizzati da due elementi: da una parte un segno di bocciatura per il lavoro svolto dall’Anp in questi anni (e quindi per Fatah che la governava), giudicato negativamente sia sul piano di quanto ottenuto nei “negoziati” con Israele, sia soprattutto sul piano della corruzione e della mancanza di risposte ai bisogni sociali e materiali. Hamas è risultata più credibile; dall’altra parte è stato anche un voto palese contro le politiche vergognosamente filoisraeliane e anti arabe degli Usa e quelle pilatesche dell’Unione Europea che ha pensato di barattare con i miliardi dei finanziamenti il disimpegno e l’ambiguità politica che agli occhi della popolazione è diventata insopportabile. Considerazioni iniziali sul prossimo futuro Ancora, a questa strategia della dilatazione del tempo relativamente ai rapporti di forza e agli accordi, potrebbe accompagnarsi anche il rischio di una dilatazione territoriale/ideologica della prospettiva globale, nel senso di accoppiare alla visione israeliana di “Israele terra degli ebrei”, il contrapposto riferito all’islam. Si ritornerebbe in questo senso ad una visione pan araba in versione islamica del conflitto, travalicando l’aspetto strettamente nazionale e territoriale – di sicuro quello riferito al ’67- del conflitto, per modificarne in maniera radicale prospettive e protagonisti. I pericoli sono molti ma ci sono anche molte risorse a favore del popolo
palestinese. Due di queste provavano a comunicarcele alcuni palestinesi che
abbiamo incontrato. Una considerazione a parte sulla sinistra palestinese - senza permetterci
critiche tipo “sono così stupidi da dividersi in mille rivoli”,
visto che la nostra esperienza di sinistra italiana ed europea è segnata
da una storia di gruppetti settari e inefficaci, e ancora oggi non siamo poi
così diversi. Ma queste considerazioni sono parte di una discussione collettiva che la rete di Action for Peace e delle altre organizzazioni che sostengono i diritti dei palestinesi e una pace giusta in Palestina/Israele devono fare a partire da una considerazione per noi scontata sul proseguimento – ancora più forte – del nostro impegno in questa direzione. Perché l’occupazione continua e i progetti di espansione della colonizzazione dei territori palestinesi (con il Muro, gli insediamenti, le decine di “by-pass roads” ecc.) sono sempre più forti.
|
|||||||||||||||||
Domande sul dopo Gaza di Jamil Hilal agosto 2005 Traduzione di Piera Redael “E' chiaro a tutti che (la striscia di Gaza) non farà mai parte dello stato di Israele, quale che sia l'accordo raggiunto per una soluzione permanente…(quindi) consacreremo le nostre energie ai territori che sono più importanti per garantire la nostra sopravvivenza, cioè la Galilea, il Negev, l'area della Grande Gerusalemme, i blocchi degli insediamenti in Cisgiordania e le zone rilevanti per la nostra sicurezza nella valle del Giordano.” ( da un discorso di Sharon al Congresso dell'Agenzia ebraica a Gerusalemme il 28/6/2005 e riferito dal quotidiano londinese Al-Hayyat il 29/06/2005) |
|||||||||||||||||
|
fonte Misna.org e Cacao Elefante del 10/10/2005 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||